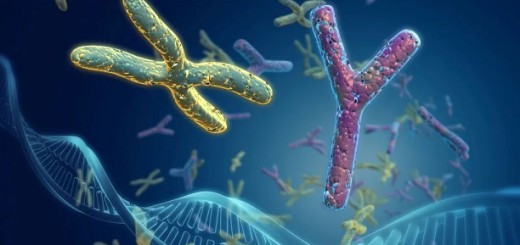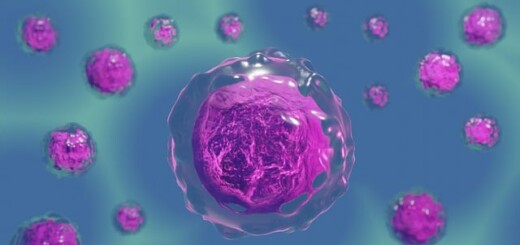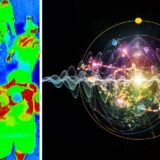Virus epatici, nuova molecola blocca l’ingresso della Delta nel fegato

Roma, 7 dicembre 2023 – I virus dell’epatite, in particolare la C e la Delta, sono da sempre nemici giurati della salute del fegato. Da qualche tempo, però, le conquiste della ricerca scientifica stanno consentendo progressi insperati nelle terapie. Farmaci che, tuttavia, per avere efficacia devono essere usati in tempo ingaggiando una lotta col virus per stanarlo nelle fasce di popolazione in cui si può annidare.
Il tema è stato trattato a Firenze, durante un simposio che si è svolto durante il congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, SIMIT. Il filo conduttore del contrasto epidemiologico ai due sottotipi di epatite è indubbiamente il ruolo cruciale degli screening, come strategia di salute pubblica, ma con variabili e peculiarità da tenere bene a mente.
Ad esempio, come spiega Maurizia Brunetto, direttore dell’unità operativa Epatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa, “l’epatite Delta è una malattia rara, perché si genera nei soggetti portatori del virus dell’epatite B che hanno una coinfezione o una superinfezione con il virus dell’epatite Delta. Si stima essere prevalente, a livello italiano, in circa il 7-8% di portatori di HBV”.
Ovvero, appunto, dell’hepatitis B virus. “Quindi – aggiunge – si tratta di un numero relativamente modesto di soggetti. Il problema, però, è che la coinfezione, ma soprattutto la superinfezione induce un danno epatico severo a rapida evoluzione. Questo vuol dire che abbiamo soggetti con cirrosi e complicanze prima dei 50 anni, quindi siamo dinanzi a una malattia davvero molto severa con un impatto sull’aspettativa di vita del paziente coinfetto molto drammatica”.
Le linee guida europee non possono che essere stringenti e suggerire, di rimando, a tutti i pazienti positivi all’epatite B di sottoporsi, almeno una volta nella loro vita, a un test per individuare gli anticorpi specifici per la Delta.
“Purtroppo i dati di sorveglianza ci dicono che questo non succede – ammette Brunetto – una percentuale variabile, in Italia per fortuna non molto elevata ma comunque del 20-25%, dei soggetti interessati non viene sottoposta a screening. Questo significa che l’eventuale infezione non viene identificata. In altre nazioni europee la situazione è ben più grave”.
La fascia di popolazione più a rischio ha una media di 50-60 anni, in sostanza una coda demografica dell’epidemia sviluppatasi in Italia a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, ma attualmente, fa sapere ancora Brunetto, “più del 50% dei casi, almeno nella mia esperienza, riguarda stranieri che hanno un’età media di 35 anni: il 70% di loro ha cirrosi”.
La silver linings, il risvolto positivo, è che negli ultimi tempi l’approccio terapeutico ha conosciuto un balzo in avanti. Merito di una nuova molecola, la bulevirtide, in grado di bloccare l’ingresso del virus e la sua diffusione nel fegato. Arrivata prima in modalità compassionevole e, successivamente, fornita dallo Stato, un recente studio mostra risultati lusinghieri.
“È un farmaco molto innovativo – spiega ancora la specialista – perché dopo 6-12 mesi di trattamento in oltre il 70% dei pazienti trattati abbiamo visto una importante caduta dei livelli del virus, pari a 2 logaritmi, ma soprattutto un abbattimento della transaminasi”. Risultati ancora più apprezzabili, considerato che si tratta di studi di pratica clinica “condotti in pazienti con malattia in fase avanzata e che dimostrano un miglioramento clinico della sintesi epatica, dei livelli delle piastrine e sul carico della malattia”. Un cambio di paradigma che risalta ancora di più se si considera l’opzione terapeutica d’elezione: l’interferone in presenza di cirrosi diventa molto difficile da dosare, lasciando dunque “orfani” di una cura.
Non è questo il rischio che corrono i pazienti colpiti da epatite C che, ormai da anni, possono contare su un farmaco in grado di spazzare via il virus. Il problema, in questo frangente, è andare a caccia della carica virale dove si può nascondere: in alcune popolazioni target, ovvero fra tossicodipendenti e detenuti in carcere, ma anche nella popolazione generale.
Il vero silver bullet – il proiettile magico, in particolare per centrare il traguardo dell’eradicazione in Italia e nel mondo nel 2030 – è una volta di più lo screening. In Italia con un decreto del 2020 è stato attivato un fondo specifico dal valore di 71,5 milioni per testare i soggetti a rischio, ma anche alcune fasce della popolazione, facendo emergere circa 10 mila nuovi casi con infezione attiva.
“L’Italia è a buon punto – racconta Loreta Kondili, ricercatrice del centro nazionale per la salute globale dell’Istituto Superiore di Sanità – possiamo dire che i risultati sono soddisfacenti, anche se in Italia sono 14 le Regioni che hanno attivato lo screening per la popolazione generale e quasi 18 Regioni lo hanno fatto o lo stanno facendo per le popolazioni chiave”.
Farà la differenza, dunque, insistere sul monitoraggio e sull’indagine prorogando il fondo oltre il 2023 ed estendendo lo screening all’intera popolazione. Attività da affiancare, ad avviso di Kondili, a un’efficace azione di sensibilizzazione da parte delle Regioni verso i pazienti, ma anche nei confronti dei medici specialisti.