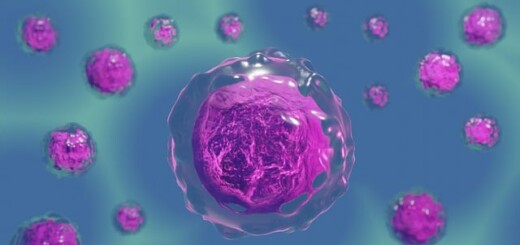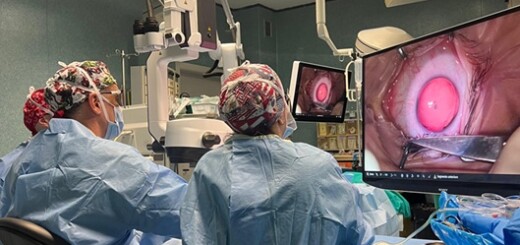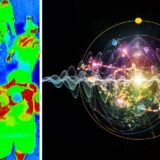Terapia dell’obesità: dalla modulazione del microbiota alla pillola ‘brucia-grasso’. Italia leader nella ricerca


Roma, 24 ottobre 2022 – L’obesità e le malattie correlate (in particolare il diabete di tipo 2), sono al centro di una vera e propria pandemia, che ha risvolti umani, clinici e socio-economici enormi. È dunque imperativo trovare soluzioni terapeutiche. E i primi importanti risultati concreti di questo sforzo di ricerca planetario si stanno cominciando a vedere, con le terapie già approdate alla pratica clinica e quelle di prossimo arrivo.
Ma il futuro è ancora più roseo e forse siamo ad un passo dal poter affrontare ad armi pari questo nemico così pervasivo e difficile da sconfiggere. Il congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) dedica a questo argomento una sessione dal titolo “Obesità: una ‘nuova malattia internistica’”.

“La Commissione Europea – ricorda il prof. Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) – ha recentemente riconosciuto che l’obesità è una malattia cronica, recidivante e progressiva e come tale non è più soltanto un fattore di rischio per malattie cardio-metaboliche, epatiche o respiratorie. Le strategie terapeutiche basate sul cambiamento di stile vita sono state negli ultimi affiancate da farmaci efficaci e sicuri basati sugli agonisti del recettore del GLP-1 che si stanno arricchendo di nuovi poli-agonisti, che utilizzano due o tre molecole ormonali. Lo sviluppo di questi nuovi farmaci per la cura dell’obesità apre nuovi scenari non solo per il trattamento del sovrappeso, ma anche per i possibili benefici in termini di prevenzione cardiovascolare”.
La carica dei nuovi farmaci contro l’obesità: ecco i farmaci di oggi e di domani che potrebbero relegare la chirurgia ai soli casi gravi
La farmacoterapia è un pilastro nella lotta all’obesità e alle sue complicanze. “Gli agonisti recettoriali del GLP-1 e i poliagonisti recettoriali, o l’associazione di alcuni di essi – spiega Paolo Sbraccia, professore ordinario di Medicina Interna nel Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e Centro Medico dell’Obesità del Policlinico Tor Vergata – rappresentano al momento soluzioni farmacoterapiche molto efficaci e sicure per la perdita di peso ed il suo mantenimento. Queste nuove classi di farmaci nei soggetti con diabete riducono inoltre il rischio cardiovascolare sia indirettamente, attraverso il calo ponderale, che direttamente, attraverso effetti anti-aterogeni. I risultati dei trial in corso, disegnati per verificare se tali farmaci riducano il rischio di eventi cardiovascolari anche nei pazienti con obesità non diabetici, ci diranno se l’obesità dovrà essere inquadrata come un equivalente di malattia cardiovascolare”.
Quello che stiamo vivendo è un momento magico e molto particolare nella storia del trattamento dell’obesità perché finalmente sono a disposizione farmaci molto efficaci, con un profilo di sicurezza ottimo e in grado di proteggere contro gli eventi cardiovascolari, dalla steatosi epatica, dall’infertilità, e altri ancora.
“L’obesità – prosegue il prof. Sbraccia – è una malattia cronica, recidivante e progressiva (come stabilito anche dalla Commissione Europea) e questa accezione la colloca nel novero delle malattie curabili con i nuovi farmaci, che hanno un profilo di efficacia e sicurezza sempre maggiore. Questo naturalmente non vuol dire che l’approccio multidisciplinare, la terapia cognitivo-comportamentale e nei casi più gravi la chirurgia bariatrica, verranno spazzati via. Ma certamente il pilastro terapeutico della farmacoterapia è destinato a rinforzarsi sempre di più, mentre lo spazio della chirurgia si andrà assottigliando”.
Attualmente sono a disposizione farmaci già molto validi come la liraglutide a somministrazione quotidiana, che ha però un’efficacia limitata sul calo ponderale (la perdita attesa è inferiore al 10% del basale). “A breve però – anticipa il prof. Sbraccia – è atteso l’arrivo della semaglutide 2,4 mg, un GLP-1 agonista a somministrazione iniettiva settimanale, che consente di perdere oltre il 15% del peso corporeo (nei trial clinici, oltre un terzo dei soggetti trattati hanno superato il 20% di perdita del peso iniziale). Sono inoltre in corso trial clinici sull’associazione semaglutide-cagrilintide (un analogo a lunga emivita dell’amilina) che consentirebbe di superare anche la soglia 20% di perdita di peso iniziale”.
Si tratta insomma di risultati che cominciano a rosicchiare il campo della chirurgia bariatrica. “Su un altro fronte – prosegue il prof. Sbraccia – il trial SURMOUNT-1 sulla tirzepatide (un doppio analogo GLP-1/GIP o dual agonist) a somministrazione settimanale ha mostrato dati di estremo interesse, con una metà dei pazienti trattati che superano il 25% di calo ponderale”. Insomma, abbiamo di fronte prospettive notevoli nel campo della terapia dell’obesità. Questi farmaci sono tutti ‘costruiti’ intorno all’azione di una serie di ormoni gastrointestinali che agiscono sia sull’apparato gastro-intestinale, che a livello centrale, nella regolazione del bilancio energetico.
“Più in là – anticipa il prof. Sbraccia – avremo anche i poli-agonisti e i tripli-agonisti (attivi sui recettori di GLP-1, GIP e glucagone). E comunque già oggi la terapia dell’obesità ha rotto il muro del suono, consentendo di superare soglie ritenute impensabili un tempo”. E quindi per i pazienti con obesità il futuro sarà migliore. Ma non mancano i problemi. Questi farmaci hanno un costo non indifferente e attualmente sono a carico del paziente.
“Questo – sostiene il prof. Sbraccia – nel nostro sistema universalistico, introduce un problema di equità. Se poi i trial di outcome cardiovascolare, dimostrassero un’efficacia di queste terapie nelle popolazioni a rischio (chi ha già avuto un infarto o un ictus, ad esempio) certamente questo sarebbe un’altra freccia all’arco del trattamento con questi farmaci. Certo la rimborsabilità, in un sistema che deve essere sostenibile, potrebbe non essere semplice da ottenere, ma magari a fronte di questi risultati una fetta di popolazione potrebbe ottenerla”.
In pipeline inoltre è in sviluppo per l’obesità la semaglutide orale, attualmente disponibile per i soggetti con diabete. “Ritengo però che queste terapie orali – prosegue Sbraccia – andrebbero riservate ad una nicchia di pazienti, gli adolescenti quelli con il terrore dell’ago (anche se questi che si usano sono sottili come capelli). Fare una piccola iniezione a settimana, certi della biodisponibilità del farmaco somministrato per questa via, sembra ancora la via migliore”.
La pipeline dei farmaci di next generation è ricchissima e sono 25-30 quelli in sperimentazione, dai triple agonist, alle small molecule. Un florilegio di nuovi farmaci, insomma, alla stessa stregua di quanto sta succedendo nel diabete (e quasi tutte queste terapie hanno la doppia indicazione diabete/obesità).
“Se l’obesità si attesterà come vera e propria malattia – conclude Sbraccia – se avrà la dignità del ‘bollino’ di malattia cronica, perdendo al contempo lo stigma non solo sociale (il bullismo), ma clinico (quello che durante il Covid ha portato a chiudere gli ambulatori dell’obesità, salvo poi scoprire che gli obesi sono fragili e da vaccinare prioritariamente) e istituzionale (che finora non l’ha considerato un problema prioritario da affrontare), si spera che, anche grazie allo sviluppo farmacologico, questi pazienti avranno finalmente risposte ai loro problemi”.
L’obesità parte (anche) dalla testa: dal ‘bernoccolo del goloso’, ai circuiti della ‘dipendenza da cibo’, cosa ci sta insegnando la fisiologia. E l’Italia primeggia in queste ricerche
La ‘radice’ cerebrale del sovrappeso non è la stessa in tutte le persone e la comprensione della sua diversità e complessità rappresenta l’obiettivo fondamentale della ricerca futura verso la personalizzazione della prevenzione e cura dell’obesità.
“Tutta la ricerca sull’obesità – riflette la dott.ssa Patricia Iozzo, dirigente di Ricerca, Istituto di Fisiologia Clinica, CNR di Pisa e adjunct professor presso l’Università di Turku (Finlandia) – in linea di massima finora si è concentrata sull’aspetto, che ha portato a considerare come un insieme omogeneo tutti i pazienti obesi, in contrapposizione ai normopeso, come se questi pazienti fossero tutti ‘uguali’ dal punto di vista della causa. Questo ha portato a risultati confondenti perché all’interno della popolazione degli ‘obesi’ ci sono tante fattispecie e purtroppo finora abbiamo risultati più derivanti da questo tipo di ricerche, che da quelle che tengono in considerazione la diversità”.
Nell’ultimo periodo, invece, si stanno cominciando a prendere in esame sottogruppi di pazienti con obesità e si sta cominciando a capire che i meccanismi, le cause, ma anche quello che sollecita l’appetito, variano molto da un individuo all’altro. “Un filone di ricerca – rivela la dott.ssa Iozzo – sta prendendo in esame l’associazione tra struttura e funzioni del cervello delle persone con obesità e l’influenza della genetica. Uno studio ha dimostrato che i portatori di varianti del gene FTO, spesso associate all’obesità, presentano una struttura cerebrale particolare, cioè una riduzione di volume di alcune parti di cervello che esercitano un controllo di inibizione, di freno delle ‘tentazioni’ e sono legate anche alla memoria; siamo dunque nella parte ‘superiore’ del cervello, quella del controllo e della memoria, non quella istintiva ipotalamica o mesolimbica”.
Uno studio condotto al CNR di Pisa in collaborazione con la Fondazione G. Monasterio di Pisa e con l’Università di Bologna (prof. Uberto Pagotto) ha invece esplorato la funzione del cervello (attraverso la tomografia a emissione di positroni PET con glucosio marcato) delle persone con obesità, andando a valutare quanto glucosio consumano alcune regioni quando le persone vengono sollecitate con la vista, l’odore e il gusto di un particolare cibo ‘appetibile’ (come la cioccolata) rispetto ad uno neutrale.
“Abbiamo esaminato alcune donne in sovrappeso – ricorda la dott.ssa Iozzo – diverse tra loro per i risultati ottenuti in una scala di ‘dipendenza’ dal cibo (che significa la consapevolezza della negatività di un’azione – ad esempio mangiare un cibo che fa male – ma compierla ugualmente), ma senza veri e propri disturbi del comportamento alimentare. Nelle donne con atteggiamento di dipendenza abbiamo osservato un netto sbilanciamento tra le varie regioni cerebrali (quelle che portano a desiderare il cibo erano molto attivate alla visione del cibo appetibile, mentre le regioni che portano a controllare questo impulso erano poco attivate). Questo non accadeva invece nelle persone con lo stesso sovrappeso ma senza un atteggiamento di dipendenza nei confronti del cibo. In questo modo abbiamo dimostrato l’esistenza di uno sbilanciamento funzionale nella risposta metabolica del cervello che favorisce il desiderio a dispetto del controllo. Questo sbilanciamento è risultato presente nel 61% dei casi”.
Questi studi per ora sono fisiologia pura, ma in quello che sta emergendo c’è già in embrione la possibilità di un trattamento basato su queste scoperte. “Già oggi – afferma la dott.ssa Iozzo – possiamo proporre alcuni interventi, in grado di migliorare la funzione del cervello e in parte anche la sua struttura, e questi sono: la perdita di peso, il tipo di dieta e l’esercizio fisico. La somministrazione di insulina direttamente nel cervello è un’altra terapia al vaglio, essendo l’insulina un ormone che inibisce l’appetito. Ma l’approccio più promettente, anche perché più ‘naturale’ è lo studio del microbiota intestinale, che differisce da una persona all’altra. La manipolazione della dieta in maniera personalizzata e specifica per le caratteristiche di quella persona e del processo cerebrale che vogliamo modificare, potrebbe rappresentare in futuro una risorsa, anche perché rappresenta un approccio non invasivo, che non interferisce troppo pesantemente con la funzione cerebrale che è molto delicata. Ci sono molti studi in questo senso”.
Cosa succede quando si ammala l’organo adiposo endocrino e quali terapie ‘convinceranno’ il grasso a ‘bruciare’ sé stesso
L’obesità può essere considerata una malattia anche secondo la definizione di uno dei padri della medicina moderna, Gian Battista Morgagni (Padova 1682-1771) che parlava di “malattia quando si accerta che sia presente un organo con evidenti segni di patologia”.
“Nell’uomo – ricorda il prof. Saverio Cinti, direttore Centro dell’Obesità, Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), Ancona – i tessuti adiposi (sia il cosiddetto grasso ‘bianco’, che quello ‘bruno’) formano un vero e proprio organo: il cosiddetto ‘organo adiposo endocrino’. E quest’organo negli obesi è patologico perché l’ipertrofia (aumento di volume) delle cellule adipose, che cercano in questo modo di immagazzinare quanta più energia possibile, induce la comparsa di un’infiammazione cronica di basso grado. Questa infiammazione è causata dalla morte di questi adipociti ipertrofici, che in questo modo lasciano tanti ‘detriti’ che devono essere riassorbiti dall’organismo”.
“Deputati a questa sorta di ‘waste management’ sono i macrofagi, cellule infiammatorie specializzate nella ‘rimozione dei detriti’, che però nello svolgimento del loro lavoro, producono anche sostanze che vanno ad interferire con il recettore dell’insulina – spiega il prof. Cinti – E questo porta ad una ridotta funzionalità dell’insulina stessa (‘resistenza’ insulinica). In un primo tempo il pancreas cerca di compensare producendo più insulina, ma poi esaurisce la sua funzione; e il crollo dei livelli di insulina conseguente è alla base della comparsa del diabete di tipo 2”.
Ma c’è dell’altro. “Le cellule del grasso viscerale (quella della ‘pancia’) – afferma il prof. Cinti – muoiono prima di quelle del sottocutaneo; ecco perché l’accumulo di grasso a livello viscerale, più tipico dei maschi (le donne tendono ad accumulare grasso soprattutto a livello sottocutaneo) risulta più pericoloso da un punto di vista metabolico e può facilitare la comparsa di diabete di tipo 2”.
Il tessuto adiposo bianco (WAT) e quello bruno (BAT) hanno compiti molto diversi; il primo, immagazzina energia (sotto forma di trigliceridi) da ridistribuire poi all’organismo (come acidi grassi liberi) negli intervalli tra i pasti; il grasso bruno invece immagazzina i trigliceridi in un modo particolare, così da poterli rilasciare in maniera rapida e massiva per una particolare funzione dei mitocondri, che è quella di utilizzare l’energia per generare calore (termogenesi).
Le due tipologie di tessuto adiposo hanno una buona capacità di adattamento e, a seconda delle esigenze, possono ‘trasformarsi’ uno nell’altro; così ad esempio, in seguito all’esposizione cronica al freddo, il tessuto adiposo bianco si converte in bruno (‘browning’), mentre in risposta ad un apporto eccessivo e cronico di energia (obesità), il tessuto bruno si trasforma in bianco (‘whitening’).
“Diversi studi su modello animale (il topo) – conclude il prof. Cinti – hanno dimostrato che la dispersione dell’energia, operata dal tessuto adiposo bruno, può essere sfruttata per trattare obesità e diabete 2 nel topo. Cominciano ad accumularsi evidenze che l’imbrunimento del tessuto adiposo bianco potrebbe avere effetti favorevoli anche nell’uomo e dunque rappresentare un futuro target terapeutico per il trattamento dell’obesità”.
Un recente lavoro del gruppo del prof. Cinti ha evidenziato come l’importanza dell’infiammazione del grasso viscerale negli obesi possa giocare un ruolo patogenetico nel Covid-19. “Lo studio, condotto su 19 pazienti con Covid-19 e 23 controlli – spiega il prof. Cinti – ha dimostrato che il 100% dei pazienti COVID erano affetti da embolia polmonare lipidica, verisimilmente dovuta all’iper-infiammazione del loro grasso viscerale (doppia rispetto ai controlli). Inoltre, abbiamo dimostrato che le membrane jaline (presenti nel 100% dei pazienti COVID), responsabili del distress respiratorio, sono di natura lipidica con aspetti di transizione tra l’embolia grassosa e le membrane jaline. Questi dati offrono una possibile spiegazione sia al fatto che la polmonite da Covid sia spesso bilaterale, che alla prognosi peggiore nei soggetti con obesità viscerale”.