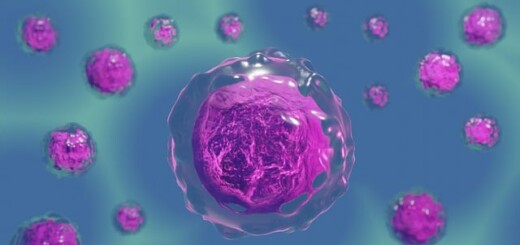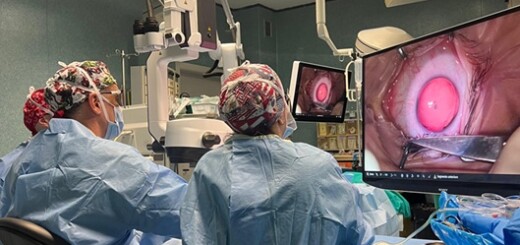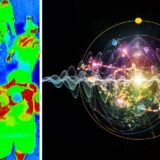Pediatria, il ruolo della genetica. Come affrontare i pazienti Covid con decorso grave

Si è conclusa la XXIII edizione del Congresso Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica con un’importante intervento del ricercatore italiano dell’ NIH di Washington sull’analisi dei meccanismi genetici responsabili di malattie come l’immunodeficienza combinata grave (o SCID, la malattia dei “bambini bolla” che annulla le difese immunitarie), che ha permesso di curare oltre il 90% dei bambini che ne soffrono. Ma le stesse ricerche aiutano anche a comprendere perché alcuni pazienti Covid hanno un decorso più severo

Milano, 26 aprile 2021 – È un viaggio nella conoscenza dei deficit dell’immunità quello compiuto da Luigi Notarangelo, Direttore del Laboratorio di Immunologia Clinica e Microbiologia dei NIH (National Institute of Health) di Washington nel suo intervento all’ultima giornata del Congresso SIAIP organizzato e presieduto dal prof. Gian Luigi Marseglia Direttore della Clinica pediatrica dell’Università di Pavia- Policlinico San Matteo.
I difetti genetici
“In passato, quando ancora si ignoravano le basi cellulari e molecolari di queste malattie, la suscettibilità alle infezioni era l’elemento fondamentale per definirle clinicamente. Nel corso degli anni però le cose sono cambiate a diversi livelli: si è visto che esistono dei difetti congeniti dell’immunità che comportano una predisposizione selettiva nei confronti di alcuni germi (per esempio i micobatteri atipici) – ricorda l’esperto – ma non un aumentato rischio infettivo nei confronti di altri agenti patogeni e si è anche scoperto che, accanto alle infezioni, un elemento fondante della presentazione clinica di queste malattie può essere rappresentato anche da altre manifestazioni di disreattività del sistema immunitario, come l’autoimmunità”.

La rivoluzione nella conoscenza e comprensione di queste malattie è avvenuta a partire dagli anni ‘90, con il sequenziamento del genoma umano e la semplificazione delle tecniche di indagine molecolare che hanno consentito di comprendere le basi genetiche di molte malattie.
“In circa 25 anni il numero di geni identificati è passato da una decina a oltre 450 – sottolinea Notarangelo – L’approfondimento delle conoscenze ha portato a comprendere che, contrariamente a quanto si pensava nel passato, cioè che a un difetto genetico corrispondesse una determinata malattia, si possono avere quadri clinici assolutamente identici sottesi da difetti genetici diversi e d’altra parte difetti genetici all’interno dello stesso gene possono dare quadri clinici assolutamente differenti fra di loro. Per esempio, i soggetti con un difetto grave dei geni RAG, importanti per la produzione dei linfociti B e T, non sono in grado di produrre queste cellule e sono quindi esposti a infezioni gravissime fin del primo periodo di vita, si tratta delle immunodeficienze combinate gravi SCID, la malattia dei bambini bolla. Nel caso in cui il difetto sia meno severo, si hanno quadri clinici diversi. A differenza dei bambini con SCID che, se non vengono trapiantati, muoiono nell’arco dei primi anni di vita, i portatori di questi difetti arrivano invece all’età adulta ma si presentano con lesioni granulomatose sistemiche contenenti il virus del vaccino della rosolia o con quadri autoimmunitari anche importanti”.
L’evoluzione della terapia per la malattia dei “bambini bolla”
Negli ultimi anni si è assistito a profondi cambiamenti anche sul versante della terapia. “Per moltissimo tempo ci si limitava a prevenire o curare le infezione con gli antimicrobici, un intervento non curativo. Nel caso dei difetti più gravi come la SCID (Severe Combined Immune Deficiency) la rivoluzione è venuta con il trapianto di cellule staminali ematopoietiche – spiega Notarangelo – Negli anni 90 si era visto che quando il trapianto veniva effettuato nei primi mesi di vita la possibilità di sopravvivenza era decisamente migliore; in realtà quello che è emerso da uno studio condotto su un registro nordamericano è che l’aspetto importante per determinare un miglioramento della prognosi non è tanto quello di trapiantare entro i primi tre mesi e mezzo di vita, quanto lo stato clinico del bambino al momento del trapianto. Si è visto infatti che i pazienti che avevano più di 3 mesi e mezzo ma che non avevano ancora avuto infezioni presentavano una sopravvivenza paragonabile a quella di bambini trapiantati nei primi tre mesi e mezzo di vita. Questo significa che per offrire una prognosi migliore è importante diagnosticare precocemente queste malattie, cosa che può essere fatta ricorrendo allo screening neonatale”.
Il difetto genetico legato alla forma grave di Covid
Nel corso di quest’anno molte ricerche condotte nei laboratori dei NIH si sono concentrate anche sul Covid, in particolare nel tentativo di comprendere perché alcuni pazienti, sia bambini, sia adulti, vanno incontro a un decorso potenzialmente fatale.
“La nostra ipotesi di partenza era che alcuni dei soggetti che hanno sviluppato una forma particolarmente grave di Covid-19, avessero alla base un difetto genetico della capacità del sistema immunitario far fronte al virus e che al contrario soggetti che, pur presentando comorbilità, pur essendo anziani, quando vengono esposti al virus non sviluppano malattia, abbiano una costituzione genetica in grado di determinare resistenza all’infezione virale In collaborazione con diversi centri italiani (Brescia, Monza, Pavia, Foggia, Bari, Torino e Napoli) abbiamo studiato il genoma di questi soggetti adulti e bambini – spiega il ricercatore – soffermandoci in particolare su geni che sappiamo essere responsabili di forme fatali di influenza e in alcuni casi anche di raffreddore. In effetti abbiamo osservato la presenza di mutazioni a carico di questi 13 geni nel 3,5% dei pazienti con forma critica di Covid-19. Si tratta di geni importanti per produrre gli interferoni di tipo primo che nella fase iniziale di un’infezione virale, prima che si inneschino le risposte dell’immunità specifica con produzione di anticorpi e linfociti T, sono prodotti dal sistema immunitario con l’obiettivo di ridurre il più possibile la replicazione virale”.
Il ricorso a interferoni
Se per ragioni genetiche un individuo non è in grado di produrre interferoni di tipo primo, il virus rimane libero di replicarsi e riesce così a diffondersi in modo molto maggiore nell’organismo con intuibili conseguenze. Ma i ricercatori hanno fatto anche un’altra osservazione sorprendente. “Il 10% dei soggetti con Covid-19 critico senza difetti genetici aveva degli autoanticorpi contro gli interferoni di tipo primo che ne bloccavano l’attività lasciando il virus libero di replicarsi”, dice l’esperto.
Si tratta di osservazioni destinate a ripercuotersi sulla terapia con il ricorso per esempio, in una fase molto precoce della malattia, agli interferoni nei pazienti incapaci di produrli o con interventi che permettano di eliminare gli anticorpi contro gli interferoni nei pazienti che li presentano. Si tratta fra l’altro di osservazioni che non si applicano solo all’infezione da SARS-CoV-2 e che potranno essere utili per affrontare anche altre malattie.
“Di recente abbiamo pubblicato i risultati di uno studio internazionale che mostra come gli stessi autoanticorpi contro interferoni di tipo primo siano la causa frequente di una complicazione osservata dopo somministrazione del vaccino contro la febbre gialla. Il vaccino contiene un virus vivo attenuato – sottolinea Notarangelo – e alcuni soggetti, dopo averlo ricevuto, sviluppano complicanze molto gravi: abbiamo visto che oltre il 50% di questi individui presenta anticorpi neutralizzanti gli interferoni di tipo primo. Queste ricerche sul covid-19 sembrano quindi aver aperto nuovi campi di studio. Intendiamo per esempio verificare se i quadri clinici gravi di varicella o le reazioni gravi al vaccino della varicella, che pure sono descritte, sono da associare alla presenza o meno di questi anticorpi”.