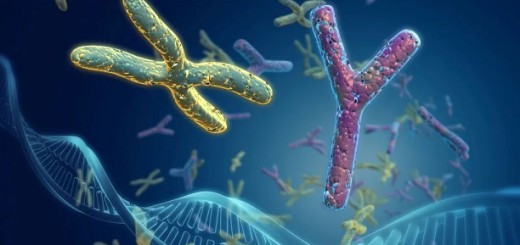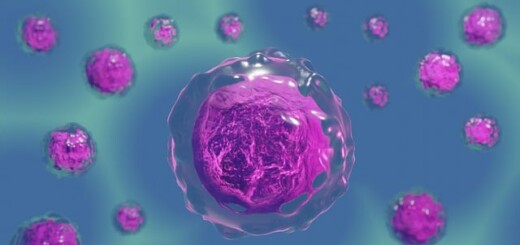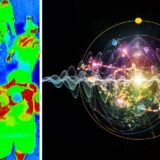Malattie infiammatorie croniche intestinali, non aumentato il rischio contagio Covid nei pazienti. Ecco le nuove terapie

Gli specialisti gastroenterologi, impegnati nella definizione del rapporto tra MICI e Covid-19, promuovono la telemedicina: durante il lockdown il 70% delle visite è stato online. Oggi un medico su due continua con tecnologia e consulti a distanza

Roma, 10 luglio 2020 – La pandemia ha messo in allarme tutti i soggetti affetti da patologie croniche, ritenuti pazienti fragili e dunque maggiormente esposti al virus. L’ipotesi iniziale, poi smentita, è stata dunque che anche i pazienti affetti da MICI – Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (malattia di Crohn o colite ulcerosa) fossero più suscettibili all’infezione da SARS-CoV-2 e ad una forma più severa di Covid-19, sia perché affetti da infiammazione cronica con danno intestinale, sia perché spesso in trattamento con farmaci immunosoppressori.
Anche il meccanismo con cui il virus agisce sembrava suggerire questa conclusione: il SARS-CoV-2 entra nell’organismo umano attraverso il legame di una glicoproteina di superficie con i recettori ACE2 altamente espressi sulle cellule epiteliali che rivestono le vie aeree (pneumociti). Da qui si attiva il sistema immunitario, generando uno stato di infiammazione acuta, nel tentativo di sopprimere la replicazione virale all’interno della cellula polmonare, che ha esiti diversi da individuo a individuo. I recettori ACE2 sono presenti anche a livello dell’epitelio intestinale, e sintomi gastrointestinali nei soggetti sani con infezione da SARS-CoV-2 sono stati riportati nel 18% degli infetti.

“È stata però riportata un’incidenza cumulativa di infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti affetti da MICI di circa lo 0.25%, percentuale lievemente inferiore a quella ‘teorica’ registrata a livello nazionale – evidenzia Alessandro Armuzzi, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore e fino a novembre 2019 Segretario Nazionale IG-IBD – Trend simili sembrano riguardare la necessità di ospedalizzazione, di ventilazione meccanica, di intubazione. I tassi di mortalità dei pazienti affetti da MICI e Covid-19, infine, sembrano anch’essi lievemente inferiori (3%) rispetto a quelli della popolazione generale, seppur con variazioni geografiche non trascurabili”.
Diversi studi nazionali e internazionali dimostrano che i fattori di rischio per un’evoluzione peggiore della Covid-19 nei pazienti affetti da MICI sono risultati essere l’età avanzata, la presenza di comorbidità, la malattia intestinale attiva e l’utilizzo di corticosteroidi.
“Al contrario, in pazienti affetti da MICI in terapia con farmaci biologici e con infezione da SARS-CoV-2 non sono risultati essere a maggior rischio di evoluzione peggiore della Covid-19 – spiega il prof. Armuzzi – Questo dato ha fatto ipotizzare che i pazienti affetti da MICI in terapia biologica possano avere un certo grado di protezione da parte di questi farmaci antinfiammatori nei confronti della tempesta citochinica generata dall’attivazione del sistema immunitario a livello polmonare, caratteristica della sindrome da distress respiratorio acuto nelle forme più gravi del Covid-19”.

Parallelamente agli aspetti clinici, la pandemia ha generato nuove esigenze nella gestione dei pazienti, a fronte di un necessario spostamento delle risorse del sistema sanitario nella lotta alla nuova infezione. Anche per la complessa gestione dei pazienti affetti da MICI è stato possibile garantire assistenza solo ai casi urgenti e ai pazienti in terapia di mantenimento con farmaci biologici endovena.
La necessità di limitare il più possibile l’entrata negli ospedali da parte di chi non ne aveva stretto bisogno ha portato quindi a una revisione delle priorità cliniche: “home delivery” di farmaci biologici da somministrare per via sottocutanea, “virtual clinic” (telefono, email, telemedicina) per i pazienti con MICI in remissione stabile, riprogrammazione di metodiche diagnostiche/terapeutiche (endoscopia, radiologia, chirurgia) non urgenti.
“Da indagini effettuate a livello internazionale, emerge che oltre il 50% dei medici intervistati desideri continuare a gestire a distanza i pazienti affetti da MICI e in remissione stabile – dichiara Alessandro Armuzzi – La telemedicina, dunque, viene vista come uno strumento da implementare e rendere ufficiale, per evitare, almeno per il prossimo periodo, il sovraffollamento degli ambulatori da parte di pazienti che possono essere controllati ‘virtualmente’, senza perdere i benefici raggiunti con un determinato tipo di terapia”.
Secondo un’indagine che ha coinvolto 42 centri di riferimento per le MICI in Italia, si è calcolato che il 70% delle visite ambulatoriali sono state effettuate con successo attraverso la telemedicina.
“Le richieste più frequenti sono state quelle relative alla televisita, con cui il paziente si può confrontare attraverso la webcam con il proprio medico di fiducia – spiega Flavio Caprioli, professore associato presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano – Questa pratica si è molto diffusa ed è stata apprezzata soprattutto dai pazienti giovani e adulti. Tra gli anziani, invece, si sono riscontrate alcune difficoltà relativo all’accesso alla tecnologia. La telemedicina si presta molto bene per le visite non urgenti, quelle di controllo, per il confronto di sintomi e per l’osservazione delle analisi del sangue, facilitando non tanto la diagnosi, quanto la gestione della malattia stessa. Nel momento in cui si è documentata un’urgenza, però, la visita è stata comunque di persona”.
“Abbiamo realizzato, con i pazienti affetti da MICI del Policlinico di Milano, un sondaggio sulla telemedicina – conclude il prof. Caprioli – Gli intervistati hanno dimostrato di gradire molto l’adozione di queste nuove tecnologie: il 91% ha dato un punteggio ‘eccellente’ (si votava da 1 a 5), dimostrando così che questo potrebbe essere un nuovo modo per ripensare la medicina per il prossimo futuro”.
Le novità sulle terapie
L’efficace gestione dei pazienti affetti da MICI durante la pandemia e il maggiore utilizzo della telemedicina sono stati possibili grazie alle nuove terapie che negli ultimi anni si sono arricchite di molecole che consentono di bersagliare selettivamente diversi meccanismi alla base dell’infiammazione, come il cortisone o la mesalazina.
“Negli ultimi venti anni – spiega Marco Daperno, Segretario Generale IG-IBD, AO Ordine Mauriziano di Torino – sono comparsi farmaci antinfiammatori biotecnologici, che consentono di bloccare specifici processi dell’infiammazione con anticorpi monoclonali (anti-TNF, anti-integrine o anti-interleukine) o piccole molecole (inibitori delle JAK). Un rilievo importante evidenziato da un recente studio promosso da IGIBD, è che l’uso di questi farmaci non sembra correlare con un maggiore rischio di esiti infausti dell’infezione da Covid-19”.