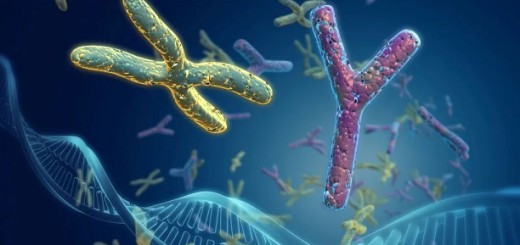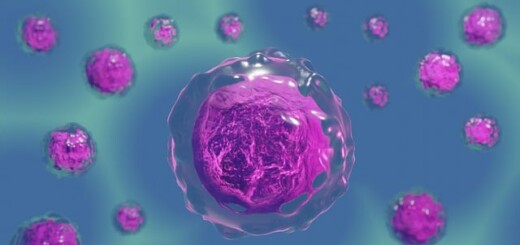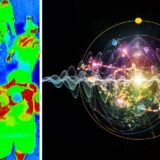Malattia di Alzheimer, la ricerca italiana lavora per identificare biomarcatori predittivi


Roma, 17 settembre 2020 – Si stima che nel mondo il 50-60% delle persone affette da demenze sia malato di Alzheimer, in Italia il dato equivale a oltre 600mila persone, mentre oltre un milione sono quelle affette da varie forme di demenza. In occasione del 21 settembre, giornata mondiale dedicata all’Alzheimer, quest’anno il dibattito dovrà tener conto del peso che ha avuto la pandemia Covid-19 sull’assistenza, considerato che il coronavirus ha colpito duramente soprattutto le fasce di popolazione ‘fragili’ e in particolare soggetti anziani con patologie plurime.
L’Alzheimer’s Disease International (ADI) assieme all’University College e alla Scuola di Economia e Scienze Sociali di Londra da mesi aggiorna le statistiche per misurare l’impatto del Covid-19 in diversi paesi e dal dossier, che riguarda anche l’Italia, si evince che quasi 9 decessi su 10 hanno riguardato persone con più di 65 anni. E tra queste, in alcuni contesti, 3 su 4 erano già affette da una demenza.
Il prof. Paolo Maria Rossini, direttore del Dipartimento di Neuroscienze – neuroriabilitazione dell’IRCCS San Raffaele Roma e responsabile del progetto nazionale Interceptor c/to Fondazione Policlinico Gemelli, sottolinea che “le informazioni a livello globale sono ancora lacunose. Relativamente all’Italia, grazie ai dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità, si sa che solo metà delle RSA interpellate ha fornito i dati relativi all’impatto della pandemia sui propri ospiti. Considerando sia i pazienti risultati positivi al tampone sia coloro che mostravano sintomi compatibili con il Covid-19 (tosse, dispnea, febbre, insufficienza respiratoria e polmonite), il tasso di mortalità medio registrato nelle strutture per anziani lungo la Penisola è risultato pari al 3,1%”.
L’emergenza ha di fatto sospeso fino a interrompere la rete di assistenza?
La normale attività di diagnosi e cura di pazienti anziani affetti da varie forme di declino cognitivo è stata sostanzialmente interrotta a tutti i livelli, inclusa l’assistenza domiciliare oltre a quella dei centri UVA (Unità Valutative Alzheimer). Non ultimo, ma da ultimo anche tutti i trials clinici con farmaci sperimentali e per lo studio di biomarcatori per la diagnosi precoce hanno subito un prolungato arresto. Insomma, tutto il mondo dell’assistenza e della ricerca che ruotava attorno al gigantesco problema della demenza si è d’incanto fermato!
E tutto questo ha comportato l’aggravarsi delle condizioni di salute dei pazienti
L’OMS ha pubblicato un documento sullo stato di benessere mentale durante la pandemia in cui si dice chiaramente che durante questa fase i soggetti con declino cognitivo minimo, specialmente coloro che si trovavano in strutture di lungo-degenza, hanno sperimentato un maggior livello di sintomi (ansia, stress, agitazione, apatia, distacco dall’ambiente e ritiro sociale).
I malati affetti da demenza, inoltre, hanno avuto ovvi problemi a ricordare di praticare le comuni precauzioni di contrasto al virus quali l’uso della mascherina, il lavaggio delle mani e – qualora colpiti dall’infezione – hanno mostrato quadri clinici decisamente più gravi. L’accesso ai pronto soccorso, l’ospedalizzazione e la morte per Covid-19 è stata decisamente più elevata nella popolazione anziana affetta da demenza rispetto a quella non demente; il tasso di mortalità tra chi aveva una demenza è risultato, infatti, più che doppio rispetto a chi invece non l’aveva. In uno studio Spagnolo in cui sono stati presi in considerazione soggetti con una forma prodromica e una conclamata di demenza, il paragone dei loro livelli cognitivi misurati attraverso batterie di test neuropsicologici prima e dopo il lockdown, ha chiaramente dimostrato un peggioramento molto importante (oltre il 40%). Analogamente, le scale per lo stress e l’ansietà dei loro caregiver, misurate nei medesimi periodi, hanno mostrato analoghi livelli di peggioramento.
Il distanziamento dai propri cari quanto ha pesato?
Le rigide limitazioni affrontate da febbraio a oggi hanno certamente aggravato il carico. Di fatto sono stati fortemente compressi i diritti umani fondamentali delle persone con demenza: dall’accesso alle cure ospedaliere ai ricoveri nelle terapie intensive, non sempre garantiti a pazienti che avevano chance di sopravvivenza limitate. Diverse sono state le esperienze estere per far sentire meno isolati gli anziani affetti da demenza: dal massiccio ricorso alla tecnologia per favorire i contatti con i parenti alla possibilità di incontrarli in spazi all’aperto, ideali anche per svolgere attività ricreative.
Sotto il profilo terapeutico ci sono novità?
Quest’anno – forse – per malati e famiglie c’è qualche motivo di speranza in più perché sembra che finalmente una delle numerose sperimentazioni con farmaci potenzialmente in grado di modificare l’andamento naturale della malattia stia per concludersi con dati incoraggianti. Massima prudenza sempre nel parlare di queste cose perché non si tratta di risultati miracolosi e perché riguarderà verosimilmente solo una fetta dell’enorme platea dei malati, ma è comunque il primo gradino di una scala lunga e impervia.
In questo caso si tratterebbe – il condizionale è d’obbligo – di un farmaco che blocca la formazione di placche di beta-amiloide – uno dei presunti killer alla base del processo di neurodegenerazione che porta alla morte delle cellule nervose e alla progressiva perdita delle funzioni cognitive – e forse che aiuta anche a ridurre quelle già formate. Ma ci sono alcuni limiti.
Il primo è la presenza consistente di placche di beta-amiloide, che riguarda solo una parte dei malati. Inoltre dai dati sin qui disponibili, sembra che l’efficacia del trattamento sia limitata alle primissime fasi della malattia, quella “prodromica” con sintomi minimi e una piena autonomia di chi non sa nemmeno di averla, probabilmente perché nelle fasi successive la possibilità di recupero – legata anche alla disponibilità di una “riserva neurale” – è completamente perduta. Inoltre si sono registrati effetti collaterali non banali (in particolare emorragie cerebrali) e i costi saranno elevati.
Ne deriva che non sarà possibile fornirlo a pioggia a larghe fasce della popolazione. Dovremo quindi (noi, come tutti i sistemi sanitari del globo) disporre di un metodo oggettivo per identificare precocemente i soggetti ad alto rischio ed intercettare al loro interno coloro che avranno le caratteristiche giuste per usufruire al meglio dalla cura.
Questo è uno dei tanti motivi per cui nacque oltre 3 anni orsono il progetto Interceptor, che vede l’Italia come primo paese al mondo che mira a identificare un insieme di biomarcatori in grado di intercettare coloro che svilupperanno la malattia, quando questa ancora non ha intaccato in modo inesorabile le loro “riserve neurali”.
Come si sta realizzando il progetto, quanti soggetti saranno coinvolti?
Interceptor è iniziato nel luglio del 2018 e sta ora completando il reclutamento dei 500 soggetti previsti attraverso 20 centri reclutatori in altrettanti ospedali italiani. Vengono studiati 6 diversi biomarcatori (genetica, liquido cerebro-spinale, risonanza magnetica, tomografia ad emisisone di positroni, test neuropsicologici innovativi, elettroencefalogramma) acquisiti al momento del reclutamento.
I 500 soggetti vengono seguiti poi per 3 anni (termine dicembre 2023) ed a quel punto capiremo quale insieme di biomarcatori fornisce le previsioni più accurate con i costi più sostenibili anche per pazienti e famiglie.
Un progetto ambizioso, che mette il nostro Paese all’avanguardia proprio nell’ottica dell’arrivo di nuovi farmaci.