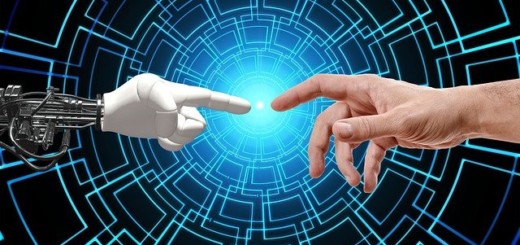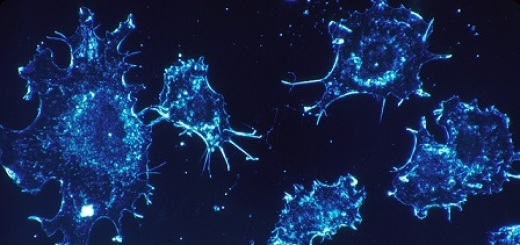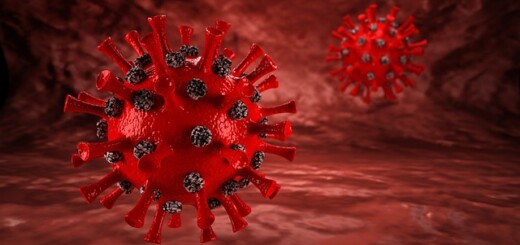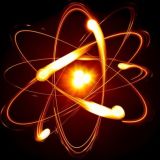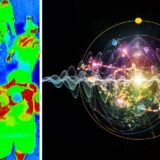Roma, 27 ottobre 2023 – Il nome, ‘soft’ (soffice, facile, leggero) non deve trarre in inganno. Si chiamano infatti ‘soft skills’, ma in medicina sono quel plus che può fare la differenza, a parità di preparazione scientifica. E la Società Italiana di Medicina Interna, sempre pronta a cogliere tendenze e suggestioni per elevare la qualità delle prestazioni degli internisti, ha dedicato all’argomento una sessione del Congresso nazionale a Rimini.
Empatia, capacità di ascolto e comunicazione forse non rappresentano requisiti essenziali per fare il medico (per quello c’è il bagaglio culturale delle hard skill, come l’anatomia, la fisiologia, e le altre materie di insegnamento classico), ma di certo fanno la differenza nell’instaurare una solida relazione medico-paziente. Che può avere ricadute importanti anche sugli esiti del trattamento ed è alla base dell’effetto ‘placebo’, ma anche di quello ‘nocebo’.
La comunicazione empatica è parte fondante del percorso di cura, aumenta la fiducia del paziente, la compliance, migliora le diagnosi e protegge il sanitario dal rischio di burn out. E soprattutto ha un solido substrato neuro-scientifico, essendo state individuate aree cerebrali deputate all’empatia. Stress e carichi eccessivi di lavoro, invece, aumentano il rischio di cancellare l’empatia nella relazione medico-paziente, portando a una ‘deumanizzazione difensiva’ che può causare un maggiore disengagement del medico nei confronti del paziente e una diminuzione della patient satisfaction.
È fondamentale dunque superare la dicotomia tra medicina ‘umanistica’ (quella incarnata dal Dr. Murray, ‘The Doctor’ del celebre quadro di Luke Fildes, esposto alla Tate Gallery di Londra) e ‘scientifica’ (quella del Dr. House, lo scienziato cinico per antonomasia) perché l’atteggiamento del medico può avere ricadute biologiche sull’organismo del paziente.
La proposta degli esperti della SIMI è dunque quella di introdurre nel corso di medicina e, in maniera ancora più mirata, nei corsi di specializzazione, un insegnamento in ‘relazione medico-paziente’, declinato nelle componenti fondamenti dell’empatia e della comunicazione. Se ne è parlato al recente Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna.

“Sino agli anni ‘80 dello scorso secolo – ricorda il prof. Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana di Medicina Interna SIMI – era opinione prevalente che lo stile comunicativo del medico durante la visita fosse ‘innato’ o, al meglio, appreso per imitazione dai maestri, presso cui il professionista si formava. Negli anni successivi questa prospettiva si è progressivamente modificata sotto la spinta della dimostrazione che alcuni stili comunicativi attenti al vissuto del paziente sono più efficaci di altri nel determinare risultati clinici quali la soddisfazione dei pazienti al termine delle visite o la loro aderenza ai trattamenti proposti”.
“I medici commettono spesso l’errore di focalizzarsi sulla condizione medica e sui risultati della cura fornita piuttosto che sugli aspetti psico-sociali che possono interessare una persona con una patologia cronica – prosegue Sesti – Per anni il linguaggio utilizzato nel colloquio con le persone affetta da patologie croniche ha avuto caratteri di giudizio e colpevolizzazione e non ha tenuto in considerazione i loro bisogni e le loro opinioni. Dovremmo sempre ricordare che molti di noi non vivono la vita delle persone con patologie croniche ed essere più consapevoli dell’impatto delle nostre parole”.

“In un mondo dominato dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale – commenta il prof. Nicola Montano, presidente eletto della Società Italiana di Medicina Interna SIMI – non possiamo dimenticare che la comunicazione è molto importante nei rapporti umani in generale e fondamentale nel rapporto medico-paziente. Una persona può avere più o meno attitudine all’empatia, ma di certo si può cercare di svilupparla. Il nostro compito come società scientifica è anche quello di andare a stimolare argomenti che purtroppo non sono materia di insegnamento universitario e che invece dovrebbero esserlo”.
“L’elemento di novità scientifica emerso negli ultimi 20 anni – ricorda Alfonso Troisi, professore associato di Psichiatria all’Università ‘Tor Vergata’ di Roma – è che gli effetti della relazione medico-paziente possono essere documentati anche in termini biologici perché possono avere ricadute sul sistema immunitario, sulle variazioni ormonali e dei neurotrasmettitori. Non si tratta insomma di un effetto esclusivamente ‘etico’, ma di qualcosa che può condizionare la maggior o minore efficacia delle terapie che vengono messe in atto. Il medico è un professionista con elevate conoscenze scientifiche, ma non può non tener conto del contesto della relazione. Queste conoscenze devono dunque entrare nella formazione dei nuovi medici e nella epistemologia della medicina contemporanea”. E dunque ‘no’ ai medici cinici anche se preparatissimi come il Dr. House perché per curare servono anche doti di empatia.
Anche l’effetto placebo e nocebo sono infatti molto influenzati dalla relazione medico-paziente. “Sull’effetto placebo – prosegue il prof. Troisi – è stata condotta una pletora di studi che lo quantificano come elemento responsabile del 40-80% del successo di una terapia. Per l’effetto nocebo invece non disponiamo di stime analoghe, forse perché i medici non amano occuparsi delle ricadute negative dei loro comportamenti. È quasi un argomento tabù. Illuminante a tal proposito è la storia del dott. Ignaz Semmelweis, un medico ungherese che lavorava in Austria, scopritore della sepsi puerperale che lui attribuì alla responsabilità dei medici che uscivano dalle sale settorie (studenti e medici ogni giorno facevano autopsie) per poi assistere le partorienti, senza lavarsi prima le mani. Per questa scoperta, quest’uomo è stato ostracizzato per anni dall’ambiente medico perché i medici non accettavano di essere la causa di questi problemi”.
Ecco forse perché si fanno ancora pochi studi sull’effetto nocebo. Ma qualcosa c’è. “Ad esempio – prosegue il prof. Troisi – in campo psichiatrico ci sono esempi di psicoterapie dimostratesi dannose per il paziente. È il caso ad esempio dei pompieri dell’11/9 o delle persone travolte dalla pandemia di Covid-19, sottoposti a interventi di ‘debriefing’ o di ‘defusing’ (disinnesco) che consistono nell’aiutare le persone che abbiano avuto un coinvolgimento traumatico in un certo evento a rielaborare i ricordi e le emozioni vissute in quelle situazioni. Bene, è stato dimostrato che questi interventi peggiorano la prognosi portando queste persone a sviluppare un disturbo post-traumatico da stress a distanza di mesi, mentre quelli lasciati ad un’elaborazione individuale, spesso stanno molto meglio”.
“L’uomo è nato per essere in relazione – afferma la dott.ssa Elena Pattini, dirigente Psicologo-Psicoterapeuta Ausl Parma e professore a contratto Università degli Studi di Parma – Possediamo addirittura aree cerebrali specifiche per l’empatia che ci consentono di entrare in connessione con le emozioni degli altri e comprenderle. All’interno di questa cornice neuro-scientifica la comunicazione empatica diventa parte fondante del percorso di cura, aumenta la fiducia del paziente, la compliance, migliora le diagnosi e protegge il sanitario dal rischio di burn out. I pazienti giudicano il saper rassicurare, mostrare comprensione, spiegare la procedura, non ignorare la loro preoccupazione, skills fondamentali per un sanitario”.
“Tuttavia – prosegue Pattini – nel contesto professionale attuale, lo stress e il carico eccessivo di lavoro aumentano il rischio di ‘deumanizzazione difensiva’ che può portare ad un maggiore disengagement del medico e ad una diminuzione della patient satisfaction. Conoscere dunque le tecniche di comunicazione empatica e i suoi effetti a livello comportamentale e neurofisiologico consente di affrontare la presa in carico del paziente in un’ottica bio-psico-sociale, che tiene conto non solo del corpo, ma anche degli effetti psicologici dell’essere in una condizione di fragilità. In questo modo l’empatia diventa un fattore protettivo per la relazione di cura e per il benessere psico-fisico sia del medico che del paziente”.
Le tecniche di comunicazione empatica sono tutte quelle modalità verbali e non che comunicano all’altro un certo tipo di accoglienza e comprensione del suo stato emotivo. Alcune frasi possono aumentare o ridurre la percezione di relazione empatica e possono essere oggetto di formazione specifica. Ma all’interno del corso di medicina non ci sono momenti dedicati.
“E la conseguenza – riflette la dott.ssa Pattini – è che una volta arrivati in corsia, studenti e specializzandi fanno fatica a relazionarsi con il dolore. E rischiano, non sapendo come gestire il dolore, né su di loro, né sul paziente, di distanziarsi emotivamente per proteggersi e per il timore appunto di non saperlo gestire. È necessario invece diventare consapevoli di come funzioniamo noi in certe situazioni e di come funziona l’altro, per creare una relazione più autentica che faccia percepire al paziente di essere ascoltato”.
Per ottenere certi risultati, ci sono proprio delle modalità comunicative da imparare. “Ad esempio – prosegue la psicologa – il dire ‘mi dispiace che lei stia male in questo momento’ o ‘mi dispiace che non abbia dormito’. Il dire ‘mi dispiace’ per una condizione di fragilità dell’altro è un esempio di ‘empatia affettiva’. Ma ci sono altri tipi di empatia come l’empatia ‘cognitiva’ come dire ‘capisco che lei in questo momento stia male’. Questo fa percepire all’altro di essere ascoltato”.
Sbagliatissimo è far percepire al paziente che non si ha tempo per lui, limitarsi a dare comunicazioni tecniche e quando il paziente domanda, liquidarlo rapidamente. “Dare la percezione ‘non ho tempo per te’ – spiega la dott.ssa Pattini – è un errore gravissimo. Come anche non guardare mai la persona e continuare a digitare al computer, senza chiedere nulla, senza sorridere. Altro errore da non fare è generalizzare, cioè usare espressioni come “non si preoccupi, tutti passano quello che sta passando lei”. La ‘generalizzazione indebita’, i ‘quantificatori universali’ (‘tutti’, ‘nessuno’, ecc) sono altre cose da non utilizzare nella comunicazione empatica. Il paziente vuole che l’attenzione sia tutta su di lui. Cosa fanno ‘tutti’, non gli interessa”.
Comunicazione non verbale
Al di là delle parole, quello che facciamo con i gesti e con le posture può influenzare molto la relazione. Cosa cambia ad esempio se il medico ‘tocca’ il paziente? “Uno studio americano – spiega il prof. Troisi – ha dimostrato che se il medico dopo aver fatto una prescrizione di un antibiotico, poggia la mano sulla spalla del paziente, dicendogli magari ‘mi raccomando’, l’aderenza alla terapia risulta molto maggiore. Piccoli elementi di comunicazione non verbale migliorano la relazione. È molto importante nella comunicazione non verbale che il medico dimostri attenzione a quello che dice il paziente, ad esempio mantenendo il contatto oculare, guardando negli occhi il paziente. Importante anche avere la capacità di modulare i tempi di intervento. Spesso i medici, anche perché pressati dal contesto, tendono ad interrompere il paziente facendo continuamente delle domande che rispettano il loro schema di raccolta delle informazioni; ma questo per il paziente può essere frustrante perché alcuni hanno bisogno di raccontare i loro sintomi in un certo modo; lasciar loro il tempo di farlo mette le cose su un piano di maggior alleanza e comunicazione”.
“Il medico deve saper decodificare anche il comportamento non verbale del paziente – continua Troisi – Bisogna ad esempio imparare a conoscere anche quei comportanti non verbali che esprimono disagio e stress anche se questo non viene manifestato a livello verbale. Sono i comportamenti di auto-contatto (es. passarsi la mano tra i capelli, grattarsi) che indicano che la persona sta provando una situazione di disagio, indipendentemente da quello che dice”.
Importante è anche chiedere alla persona cose che non hanno a che vedere solo con la malattia. “Purtroppo spesso in corsia arriva il medico con gli specializzandi e non chiede neppure il nome al paziente – ammette la dott.ssa Pattini – Ma in quel momento la persona non è solo il diabetico del letto 27; magari si chiama Giovanni, fa il commercialista e ha la passione per la pittura. Non possiamo identificare la persona con la sua malattia. La persona non è mai solo la sua malattia. Quando il paziente si sente considerato solo per la sua malattia perde la sensazione di umanità. E questo fa sì che la persona si affidi meno, segua meno le indicazioni del medico, con ricadute negative sulla guarigione. Il medico empatico insomma migliora la prognosi del paziente. E, a parità di competenze – conclude la psicologa – le persone scelgono il medico più empatico e lo raccomandano di più. La considerano una competenza fondamentale del sanitario, quasi al pari di quella tecnica”.
Una nuova materia di insegnamento
“La materia ‘relazione medico-paziente’ – suggerisce il prof. Troisi – andrebbe insomma inserita nei corsi di laurea in medicina, ma senza limitarsi all’ambito psicologico-psichiatrico. È necessario partire dalla realtà biologica di quello che accade in questa relazione, cioè dalle conseguenze biologiche dei comportamenti del medico. Oltre allo psichiatra un corso del genere andrebbe tenuto da neurofisiologi come Fabrizio Benedetti professore di Neuroscienze all’Università di Torino e membro dell’Istituto Nazionale di Neuroscienze (INN), che è il maggior esperto mondiale di effetto placebo. Il corso dovrebbe partire dalla biologia della relazione medico-paziente, passando poi ad istruzioni specifiche su quello che bisogna fare o meno”.
“La formazione deve occuparsi di empatia – sostiene la dott.ssa Pattini – a partire dal primo anno, ma in particolare dal terzo anno, quando gli studenti iniziano a frequentare la corsia e ad avere contatti con i pazienti. Questo poi deve continuare nella specializzazione perché ogni specializzazione ha pazienti specifici rispetto alla concettualità della malattia”.
La relazione medico-paziente insomma è fondamentale nei processi di cura ma ad oggi, nelle università lo spazio dedicato alla relazione medico-paziente è davvero limitato o assente. La medicina viene insegnata solo come una serie di interventi ben validati in termini scientifici che producono effetti legati fondamentalmente al meccanismo del farmaco o dell’intervento terapeutico messo in atto. “Ma questo va rivisto almeno in parte – conclude il prof. Troisi – perché la relazione medico paziente, con le ricadute dimostrate su molti sistemi fisiologici, diventa un protagonista della terapia”.