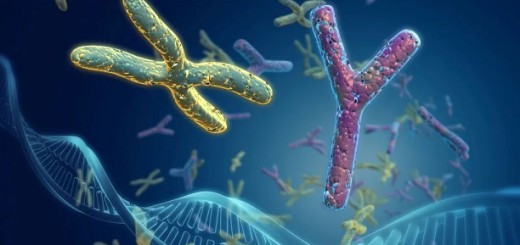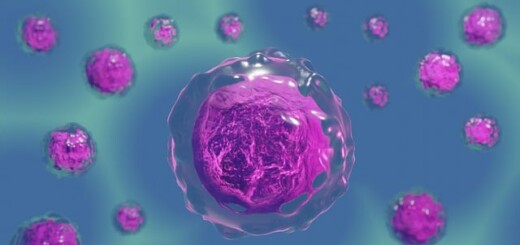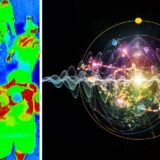Endocrinologia e metabolismo: osteoporosi, malattia di Cushing, vitamina D tra i temi del Congresso CUEM


Torino, 17 giugno 2022 – Tiroide, malattie metaboliche rare, malattia di Cushing delle quali saranno presentate le nuove linee guida diagnostiche e terapeutiche oltre ad una overview sulle terapie, metabolismo dell’osso e terapie per l’acromegalia sono solo alcuni dei temi che si alterneranno durante i lavori del CUEM 2022 in programma domani 17 giugno a Torino, al timone il prof. Ezio Ghigo, co-presidente del congresso insieme al prof. Andrea Giustina.
Nuove linee guida per la Malattia di Cushing
La Malattia di Cushing (MC) è una rara ma severa patologia endocrina, causata da un tumore ipofisario ACTH secernente, responsabile di circa il 70-80% delle forme di ipercortisolismo cronico endogeno, associata ad un aumentata morbilità e mortalità. nel 2021 più di 50 Opinion Leaders della Pituitary Society si sono espressi pubblicando una Consensus sulla rivista “The Lancet Diabetes & Endocrinology”, volta ad aggiornare le linee guida esistenti. Il trattamento di prima linea per la MC è rappresentato dalla chirurgia ipofisaria, da espletare preferibilmente presso centri di eccellenza specializzati; si associa ad un tasso di remissione di circa il 60-80%.
I tassi di recidiva pubblicati variano tra il 5 e il 35%, con la metà delle recidive che compaiono entro i primi 5 anni dopo l’intervento. La terapia medica ha recentemente acquisito un ruolo di grande rilievo rispetto al passato per lo sviluppo di nuovi e promettenti farmaci. Tre le categorie disponibili: gli inibitori della steroidogenesi surrenalica, i farmaci ad azione ipofisaria e gli antagonisti recettoriali dei glucocorticoidi.
“Gli inibitori della steroidogenesi surrenalica, storicamente disponibili quali il ketoconazolo, il metirapone, il mitotane e l’etomidato, nonché l’osilodrostat, recentemente approvato, bloccano uno o più enzimi della cascata steroidogenica, sono efficaci nel controllare l’eccesso di cortisolo, ma non sono capaci di agire direttamente sull’adenoma ipofisario ACTH-secernente” sottolinea il dott. Pivonello, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia – Sezione di Endocrinologia Università degli studi di Napoli Federico II Napoli (NA).
Al contrario, i farmaci ad azione centrale agiscono anche a livello del tumore ipofisario responsabile della MC. In particolare, il pasireotide, analogo della somatostatina, e la cabergolina, dopamino-agonista, sembrano farmaci promettenti, poiché inducono una remissione della malattia in un significativo numero di pazienti.
“Dalla pubblicazione delle ultime linee guida cliniche nel 2008 sulla sindrome di Cushing, nuove evidenze si sono accumulate, che hanno reso necessario un aggiornamento in ambito sia diagnostico che terapeutico relativo a questa complessa patologia – continua il dott. Arvat della Divisione di Endocrinologia Oncologica dell’Università di Torino – Nel 2021, la Pituitary Society ha promosso una Consensus di esperti internazionali, che ha prodotto un aggiornamento delle linee guida, con nuove raccomandazioni riguardanti l’uso di test di laboratorio, imaging, opzioni di trattamento e proposte di algoritmi per la diagnosi, la terapia ed il follow up della malattia di Cushing”.
Le nuove terapie biologiche dell’osteoporosi
Denosumab è l’anticorpo monoclonale umano che induce una rapida inibizione del riassorbimento osseo per 6 mesi. L’anticorpo si è dimostrato efficace ed è attualmente indicato nell’osteoporosi postmenopausale, indotta da cortisonici, inibitori dell’aromatasi (nei pazienti oncologici) e deprivazione di androgeni.
“Una caratteristica distintiva di denosumab è la sua possibile azione come modulatore del sistema immunitario con una possibile maggiore suscettibilità ad alcune infezioni” sottolinea il prof. Andrea Giustina Co-Presidente del CUEM e Direttore dell’Istituto di Scienze Endocrine e Metaboliche dell’Università Vita-Salute San Raffaele.
“Tuttavia – continua Giustina – nostri dati preliminari suggeriscono che le pazienti in terapia con Denosumab non avevano rischio maggiore di contrarre infezione da SARS-CoV 2 o di un Covid-19 più grave rispetto ad altre terapie anti osteoporotiche. Su questa base e grazie anche allo studi seminale da noi condotto al San Raffaele che ha dimostrato come le fratture vertebrali siano una comorbidità molto frequente del Covid-19 è venuta la raccomandazione di non sospendere le terapie per osteoporosi incluso il denosumab durante la pandemia. Un lavoro recentissimo sulla rivista internazionale Endocrine del gruppo del San Raffaele dimostra anche che avere fratture vertebrali all’ingresso in Ospedale predisponga i pazienti Covid-19 ad avere una più lenta e incompleta ripresa della funzionalità respiratoria sei mesi dopo la dimissione, potenzialmente rappresentando un fattore causale aggiuntivo del cosiddetto “long Covid”.
Al denosumab si aggiunge come strumento terapeutico il romosozumab, un anticorpo monoclonale che blocca gli effetti della proteina sclerostina e agisce principalmente accelerando la formazione dell’osso. Una dose di romosozumab consiste in due iniezioni, una immediatamente successiva all’altra, somministrate una volta al mese da un operatore sanitario. La sicurezza e l’efficacia del MAB sono state verificate in due studi clinici che hanno coinvolto un totale di oltre 11.000 donne con osteoporosi postmenopausale. Nel primo studio, ha ridotto il rischio di nuove fratture vertebrali del 73% a 12 mesi rispetto al placebo.
Romosozumab è la prima terapia per l’osteoporosi con un vero doppio meccanismo d’azione. Somministrato in un solo anno, principalmente a causa della rapidità della sua attività anabolica, fornisce guadagni di BMD maggiori rispetto a qualsiasi altro agente e riduzioni di fratture sia vertebrali che cliniche entro un anno.
Seguito da un anti-riassorbimento, i guadagni di BMD e l’efficacia anti-frattura di questo trattamento sequenziale, particolarmente consigliato in pazienti ad altissimo e imminente rischio, è tale da fornire una potenziale “cura” dell’osteoporosi grave. Tuttavia il trattamento è controindicato nei pazienti con infarto miocardico o ictus – così come sottolineato dal prof. Ferrari dell’Università di Ginevra.
Vitamina D calcio e fenotipo osteometabolico del Covid-19
Il gruppo del San Raffaele è stato pioniere nell’identificare il cosiddetto fenotipo osteo-metabolico del Covid-19, che ha recentemente descritto sulla prestigiosa rivista Nature Reviews Endocrinology, di cui oltre alle già citate fratture vertebrali fanno parte l’ipovitaminosi D e l’ipocalcemia.
La vitamina D è coinvolta attivamente nella prevenzione delle infezioni acute del tratto respiratorio e, in particolare, di quella da Covid-19 attraverso la sua azione antimicrobica; è, inoltre, capace di diminuire il rischio di malattia grave, grazie alla sua azione di riduzione della risposta infiammatoria.
È emerso come, i Paesi dove il tasso di mortalità per Covid-19 è più alto, siano gli stessi in cui i livelli di vitamina D nella popolazione sono più bassi, e come soggetti ospedalizzati con forma severa di malattia, nella maggior parte dei casi, abbiano una carenza dei livelli di vitamina D circolanti.
È stato evidenziato anche come i pazienti positivi al Covid-19 avessero bassi livelli di calcio ionizzato, sia all’ingresso in reparto che durante la degenza. Questo potrebbe essere spiegato da numerosi fattori, tra cui la possibilità che il calcio entri a far parte dei meccanismi di replicazione virale con suo relativo consumo e la carenza di vitamina D.
Ciò può essere utile sia nell’uso del calcio ionizzato come marker di aggressività dell’infezione, sia, avendone conoscenza, per prevenire le complicanze che un’ipocalcemia acuta, potenzialmente grave, può innescare. È dunque possibile che il fenotipo osteometabolico condizioni l’andamento della malattia e che rappresenti un utile target per il monitoraggio e la terapia del Covid-19.