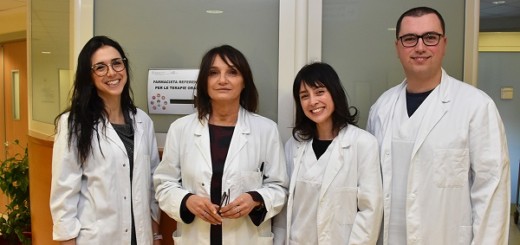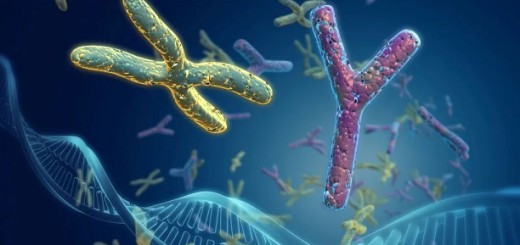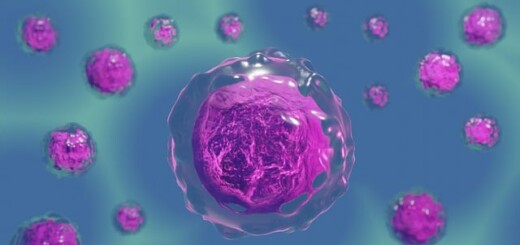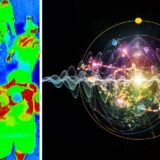Diagnosi di tumore: la rabbia verso il medico come testimone di una fine
A cura del prof. Vittorino Andreoli, specialista in Psichiatria e Neurologia

Di fronte alla diagnosi clinica si può rispondere in tre modalità differenti che non vanno rilevate attraverso risposte verbali ma, in maniera ben più significativa, attraverso il comportamento.
La prima è caratterizzata dal comportamento depressivo: il malato riconosce di trovarsi di fronte a una condizione negativa e elabora sentimenti che vanno dalla sfortuna, alla tragedia. I pensieri girano tra ingiustizia e significato dell’esistenza, al ‘colpo’ che sembra riportare la fatica alla inutilità di tutti gli sforzi di cui sempre una storia umana è ricca.
In questo caso è come buttare la spugna e perdere di vista il significato del progetto terapeutico che suggerisce il medico e che, pertanto, non è visto come il possibile guaritore, ma come il testimone di una fine. E se si segue ciò che suggerisce, lo si fa senza convinzione, con una gestualità rituale ma vuota.

La seconda si caratterizza per una lotta accesa verso l’avversità, un impegno a fare tutto il possibile per superarla. Una sorta di atteggiamento eroico che porta ad allearsi con il medico che ha fatto diagnosi e sulla stima di sé che indipendentemente dal tipo di diagnosi, prevede la lotta. In questo caso la solidarietà e il legame con il medico si rinsaldano.
La terza risposta comportamentale e la meno frequente, ma certo quella che colpisce e in qualche modo è in crescendo. Si caratterizza dallo sviluppo di una rabbia che si esprime in maniera particolare contro il medico.
Queste modalità hanno un significato importante. Non si tratta cioè di una curiosità temperamentale, ma di un vero e proprio comportamento che ha riflessi significativi sulla terapia e soprattutto sull’efficacia della cura. È stato infatti dimostrato che la risposta terapeutica risente potentemente delle emozioni e degli atteggiamenti affettivi.
Mentre le emozioni sono acute e transitorie, le risposte affettive sono durevoli. Entrambi comunque agiscono sul sistema immunitario che è il centro da cui dipendono le risposte terapeutiche a parità di indicazione medica per il caso specifico. Il sistema immunitario è l’apparato che biologicamente attiva le resistenze verso ogni forma di disturbo medico, i sistemi di difesa legati ai meccanismi propri dell’organismo.
Nel primo caso le difese immunitarie, diminuiscono notevolmente, nel secondo si rinforzano, nel terzo si crea una nuova situazione che sembra distruttiva poiché toglie al medico il ruolo terapeutico e lo si vede come colpevole della situazione espressa dalla diagnosi che definisce una condizione considerata di notevole gravità sempre.
Occorre ammettere che un notevole ruolo lo gioca il medico e la maniera con cui comunica la diagnosi. È dunque importante la condizione relazionale esistente tra medico e paziente, in particolare di fronte a diagnosi vissute dalla cultura attuale come particolarmente nefaste. È il caso di una diagnosi di neoplasia. I tumori vengono considerati oggi come la ‘peste’ del passato, una forma di malattia che viene valutata sul tempo di sopravvivenza e dunque direttamente con la morte.
Sigmund Freud sosteneva che sempre la paura è paura di morire, ma certamente ci sono della maschere che finiscono per attutire, per nascondere questo rischio. Nel caso di tumori è ancora una modalità svelata. Sulla base del diritto a conoscere la propria condizione (la verità), ma soprattutto per la particolare condizione in cui si trova la medicina del tempo presente e il suo riflesso sul singolo medico.
Egli è fortemente preoccupato e condizionato dalla responsabilità, non tanto da quella propria della deontologia (del giuramento di Ippocrate), ma dalla responsabilità penale che nel caso di intervento inadeguato tocca il Codice di Procedura Penale. I medici indagati per malpractice sono sempre di più, le condanne maggiormente frequenti e comportano la incarcerazione, oltre alla distruzione della fama che giunge a cancellare la dimensione professionale del medico costruita in tanti anni di lavoro.
Un altro effetto di questa situazione storica sono le spese assicurative per i danni professionali e, non ultima, la caduta di credibilità, di fiducia nella classe medica. E fiducia ha la stessa radice di fede.
Come risposta il medico cerca di fare diagnosi sempre più pesanti o di caricarle di rischi che ne aumentano la gravità. Il ragionamento difensivo del medico è semplice in sé, ma disastroso per il paziente.
Il medico assume il principio che è meglio presentare un quadro di gran lunga peggiore della prognosi attesa, per evitare che eventuali aggravamenti non vengano attribuiti alla cattiva pratica terapeutica. A ciò si legano le firme del paziente o dei familiari su protocolli che sottolineano i rischi di un intervento chirurgico, ma anche di una terapia medica.
In questa atmosfera si pone il terrore delle neoplasie e la paura anche delle forme cliniche meno gravi, ma ‘aggravate’ per la difesa medica e della stessa struttura ospedaliera in cui la cura avviene.
L’esempio del tumore è paradigmatico: oggi il 60 per cento dei casi viene risolto, ma questa vittoria clinica non ha minimamente toccato il significato che questa diagnosi continua ad avere nella popolazione in generale.
Tali richiami sono significativi per affrontare il tema della risposta rabbiosa verso il medico che lo pone sotto accusa e persino sotto giudizio: cessa il rapporto corretto e si finisce per giungere alla denigrazione e persino alla vendetta o al maltrattamento del terapeuta. Un vero “ostacolo nei percorsi di cura”.
Dobbiamo riportare ora la genesi della rabbia. Tutto parte dalla frustrazione che è un sentimento di malessere che una persona prova in un determinato ambiente o in contatto con una persona. Si riduce ad un una sensazione di non accettazione , di trovarsi in un ambito in cui non si è capiti o valutati secondo le aspettative. Una sensazione di rifiuto.
Sovente si tratta di condizioni in cui non è possibile reagire o chiedere spiegazioni, magari per il posto in cui ci si trova e che lo rende impossibile: sul lavoro, di fronte ad una persona che esercita una autorità e da cui dipende la propria condizione sociale.
Una frustrazione che si accumula nel ripetersi o nella sua sommazione ad altre forme di disadattamento o di ‘ingiustizia’ subita.
La frustrazione accumulata si trasforma in rabbia che si può definire una condizione di violenza interiore che viene mantenuta sotto controllo, ma che raggiunta una certa intensità si libera: e ciò accade per lo più in ambienti che permettano un maggior senso di ‘libertà’ ( come in famiglia). Si usano espressioni violente verbali: psicologiche o fisiche verso persone che certamente non l’hanno generata e magari si sono limitate a uno sgarbo che ha permesso a quel potenziale di trasformarsi paradossalmente in violenza contro, persino, persone ‘care’.
La dinamica dunque è data dalla sequenza frustrazione-rabbia-violenza. La rabbia è sempre contro qualcuno che ne è la causa ma si trasforma in violenza diretta a chi sovente non l’ha generata.
Si potrebbe anche dire per paradosso che comunque ad essere colpito è sempre anche chi prova rabbia perché alla fine il ‘peso’ ricade su di sé. La violenza agita, mette in una luce negativa chi la sfoga, fino a ritenerlo particolarmente colpevole di comportamenti violenti ingiustificati. È dunque viene definito cattivo e incapace di frenare i propri istinti malvagi.
La rabbia comunque, e ritorniamo al tema della cura, muta completamente i rapporti interpersonali. La si potrebbe chiamare “sindrome di Giobbe” (se non sembrasse irrispettoso): un uomo giusto che ad un certo momento è tormentato con ogni male possibile e da ogni disturbo mandato da Dio, mentre si è sempre mostrato rispettoso e ha seguito i principi divini.
La rabbia si mostra, anche se mascherata, al medico, alla equipe che lo cura accusandoli sovente di inadempienze e di superficialità. Se la rabbia si sposta su colui che ha fatto diagnosi, accadono fenomeni di violenza che la cronaca riporta contro il proprio terapeuta.

Dopo aver riferito i fondamenti della tematica che viene affrontata negli incontri romani con il prof. Paolo Marchetti, si riesce a cogliere l’importanza di un fenomeno in gran parte nuovo per le implicanze che ha nel proseguire la cura e soprattutto nel farla con la collaborazione necessaria e positiva per i riflessi sul sistema immunitario, che sempre più risulta il vero mezzo per combattere la malattia tumorale.
Non a caso è nell’ambito oncologico che viene trattato questo fenomeno nei convegni. Sono due i suggerimenti emersi:
- Non parlare mai di morte nella diagnosi: sovente si afferma la presenza del tumore con o senza metastasi e si dà l’attesa di vita senza o con terapia. Il riferimento è dunque il tempo di vita, la morte. E questo un personaggio che porta all’esasperazione e a risposte di vera distruttività, poiché si vede la morte come se fosse li ad attendere.
- Occorre elaborare la rabbia e dunque non rispondere alla rabbia con rabbia o con violenza, ma elaborarla, significa prenderla in considerazione, renderla manifesta e trasformarla in energia positiva. È da considerare che la rabbia è un accumulo di energia che, per quanto non adeguata è meglio dell’abbandono depressivo, della perdita della speranza e quindi di una passività terapeutica che non è mai neutra, poiché incide negativamente sul sistema immunitario. Una energia da spendere adeguatamente in sintonia con il terapeuta. Si tratta di un processo di spostamento libidico da una direzione oppositiva ad una collaborativa, che si ripercuote sul sistema immunitario nel senso della difesa. Questo processo lo deve fare uno psicoterapeuta che diventa così parte della equipe oncologica per quel paziente.
Bisogna continuare questi incontri per approfondire ulteriormente, e in maniera utile alla terapia, il problema, poiché senza la partecipazione attiva del malato non si raggiunge nemmeno ciò che invece è terapeuticamente possibile.