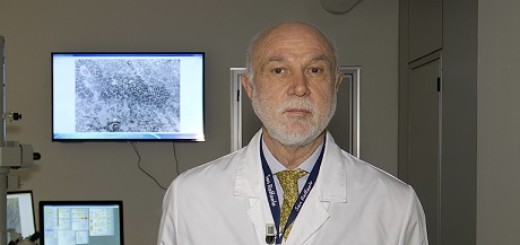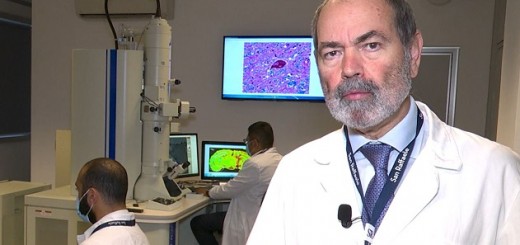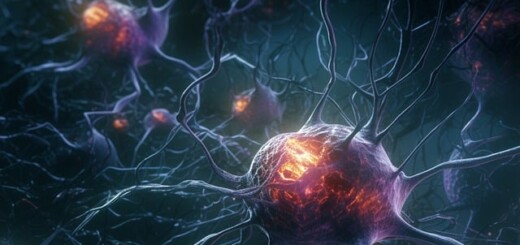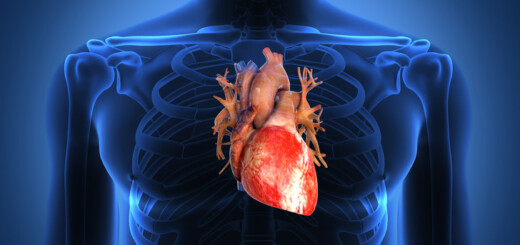Prof. Giordano Beretta, Presidente AIOM: “Bisogna recuperare quanto di positivo è nato da un’esperienza così devastante. Le priorità devono essere meno burocrazia per l’avvio di nuovi studi, maggiore utilizzo di supporti informatici e creare un sistema di rete per una valutazione globale dei pazienti”

Roma, 4 settembre 2020 – “A livello globale, nei primi sei mesi del 2020 si sono registrati 500.000 decessi da Covid-19 e più di 4.5 milioni di decessi da malattie oncologiche. La pandemia ha implementato l’innovazione e fornito un nuovo impulso allo sviluppo degli studi clinici, cosa che non è avvenuta per gli studi sul cancro. La ricerca oncologica è stata interrotta, eppure gli approcci innovativi di adattamento alla collaborazione in ambiente restrittivo, e i tempi delle pubblicazioni si sono sensibilmente ridotti durante la pandemia. Tuttavia è essenziale che venga assicurata la qualità mentre si agevola la velocità. Bisogna capitalizzare l’esperienza acquisita in questo periodo per accelerare il progresso della ricerca clinica oncologica. Tutto ciò deve avvenire unicamente a beneficio del paziente”.
Sono queste le conclusioni riportate dall’articolo “Cancer Research: The Lessons to Learn from COVID-19” sul numero di settembre 2020 di Cancer Discovery (rivista ufficiale dell’AACR). Secondo i ricercatori britannici gli studi clinici sono un aspetto dell’assistenza oncologica che ha subito una significativa interruzione durante la pandemia. Le analisi Medidata su 4.667 studi e 186.807 siti di studio indicano che si è verificato globalmente un decremento del 74% del numero dei pazienti arruolati negli studi clinici in maggio 2020, paragonato allo stesso periodo dell’anno precedente. Analogamente sono state registrate riduzioni anche ad aprile (79%) e marzo (65%).

“La pandemia Covid nel corso del 2020 si è sviluppata rapidamente con oltre 23 milioni di soggetti nel mondo risultati, alla data odierna, positivi al virus e oltre 803.000 morti – sottolinea Giordano Beretta, presidente nazionale Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) – In Italia i positivi sono stati oltre 258.000 con più di 35.000 decessi, e tali numeri sono ancora soggetti a incremento. L’impatto maggiore nel nostro paese e in tutta Europa si è verificato dalla fine di febbraio 2020 alla metà di maggio 2020, ed un graduale nuovo incremento di positività di sta evidenziando in questo mese di agosto, facendo temere una seconda ondata. Una situazione di tale entità ha comportato la necessità di modificare gli approcci dei sistemi sanitari per contenere l’epidemia e gestire la imponente mole di pazienti che afferiva alle strutture ospedaliere ed alle terapie intensive. Si è reso quindi necessario cambiare anche i comportamenti della popolazione limitando gli spostamenti, fino a veri e propri blocchi, e la possibilità di contatti interpersonali. Dal punto di vista delle attività oncologiche queste misure, ed in particolare la saturazione delle strutture ospedaliere, hanno comportato la riduzione del numero di accessi dei pazienti per le terapie, di cui sono sempre state garantite pressoché in tutte le strutture quelle indifferibili e modulate le altre sulla base del rapporto rischio/beneficio, come suggerito anche da documenti AIOM stilati nelle prime settimane dell’epidemia, ed i controlli, spesso trasformati in valutazioni telefoniche o, dove disponibili, di telemedicina. Si è anche verificata la sospensione di alcune attività diagnostiche e di prevenzione oncologica, sospese per diversi mesi tutte le procedure di screening, e la drastica riduzione degli interventi chirurgici, con molte delle sale operatorie trasformate in terapie intensive e la quasi totalità degli anestesisti impiegati in attività di terapia intensiva”.
“Anche l’attività di ricerca clinica ha subito modificazioni con la sospensione dell’arruolamento in molti studi e la ristrutturazione delle attività di monitoraggio degli stessi – prosegue Beretta – Nuove procedure si sono rese necessarie per la somministrazione dei trattamenti, che possono aver subito modifiche nella tempistica e nella esecuzione anche degli esami previsti dal protocollo, sempre al fine di ridurre il rischio per i pazienti, conseguente sia all’accesso alle strutture ospedaliere che al possibile maggior rischio di infettarsi ed avere decorso sfavorevole. Altri aspetti della ricerca clinica hanno però avuto modifiche in senso migliorativo. Nel periodo più ‘caldo’ dell’epidemia si è osservato un proliferare di studi sul trattamento dell’infezione, sulla gestione clinica dei pazienti affetti da Sars-Cov2, sulle problematiche gestionali e psicologiche correlate alla epidemia in corso. L’attività dei Comitati Etici si è accelerata e le procedure si sono snellite al punto da avere autorizzazioni a studi nel corso di pochi giorni a fronte delle settimane o mesi richiesti in precedenza. Ciò ha anche, purtroppo, a volte comportato l’attivazione di sperimentazioni non completamente supportate da dati solidi o con quesiti di scarsa rilevanza, ma ha dimostrato che è possibile una valutazione più rapida delle sperimentazioni e, conseguentemente, un avvio altrettanto rapido. E su questo punto l’articolo di Bailey et al. è molto esplicito circa il beneficio che l’esperienza COVID può comportare a vantaggio di una sburocratizzazione delle procedure di avvio di uno studio clinico. Un secondo aspetto evidenziato, dallo stesso lavoro, è legato alla possibilità di poter svolgere parte dell’attività clinica e di ricerca utilizzando strumenti informatici in luogo, sia per quanto riguarda i pazienti che per le procedure di monitoraggio da remoto. Tali supporti informatici, che abbiamo imparato ad impiegare con maggior intensità nel periodo del lockdown, possono realmente sostituire e facilitare una grossa parte dell’attività di ricerca. Ci sono poi alcuni altri aspetti che dovremmo aver imparato da questa pandemia: la necessità di una valutazione globale del paziente, non limitata alla sola patologia che stiamo studiando o curando (quanto danni secondari abbiamo successivamente riconosciuto rapportabili all’infezione virale); la necessità di un sistema di rete che coinvolga nella gestione dei pazienti un interscambio ospedale-territorio che consenta una maggiore continuità assistenziale. Questi ultimi aspetti potrebbero, a prima vista, sembrare limitati alla sola componente clinica della gestione oncologica. In realtà anche la ricerca si avvantaggerebbe con un meccanismo di rete e di gestione globale del paziente che consentirebbe una maggiore diffusione degli studi, una loro più corretta gestione ed un beneficio rilevante per tutti i pazienti oncologici per cui la richiesta di trattamenti migliori è sempre una delle più rilevanti”.
“L’articolo di Bailey et al. ci richiama quindi alla necessità di recuperare quanto di positivo possa nascere da un’esperienza così devastante – conclude Beretta – In sostanza se, come diceva il grande Eduardo in Napoli milionaria, “Ha da passà ‘a nuttata” (e prima o poi passerà), cerchiamo di utilizzare le ore di buio che restano per meglio preparaci all’alba del nuovo giorno, in modo da uscire più pronti ed efficaci in ogni necessità”.
(fonte: AIOM News)

 Salva come PDF
Salva come PDF