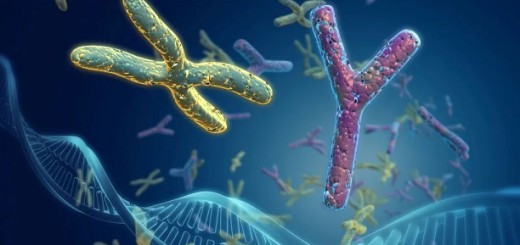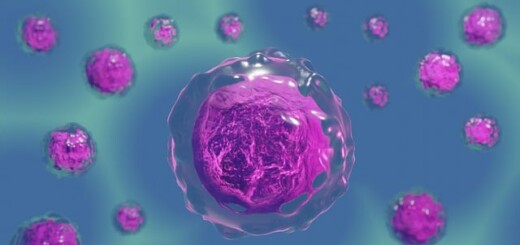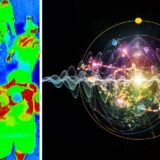Covid-19, i pazienti muoiono traditi dal loro stesso sistema immunitario. Parola d’ordine: ‘calmare la tempesta’

Il punto della prof.ssa Maria Antonietta D’Agostino, professore ordinario di Reumatologia ‘chiamato’ presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e attuale ordinario di Reumatologia presso l’Université Versailles-Saint-Quentin (Francia)

Roma, 18 aprile 2020 – È sempre più evidente che molti dei pazienti colpiti dal COVID-19 muoiono, più che per le complicanze virali, traditi dal loro stesso sistema immunitario. Perché il coronavirus uccide anche sconvolgendo le regole dell’immunità.
Nei casi più estremi provoca infatti una ‘tempesta citochinica’ (fenomeno con una serie di sinonimi e varianti: sindrome da risposta infiammatoria sistemica, sindrome da rilascio di citochine, sindrome da attivazione macrofagica, linfoistiocitosi emofagocitica), una reazione esageratamente violenta delle difese immunitarie che, anziché proteggere dal virus, attaccano tutti gli organi del paziente, fino ad ucciderlo.
Il paziente nel pieno di questa tempesta presenta in genere febbre alta, battito cardiaco accelerato, un respiro sempre più corto e un crollo dei valori di pressione arteriosa (shock). Nel suo sangue intanto sono altissimi i valori di citochine e mediatori vari dell’infiammazione, dall’interleuchina-6 all’interferon-gamma, al tumor necrosis factor alfa (TNF-alfa), alla proteina C reattiva, alla ferritina.
Gli esperti di tutto il mondo, oltre a cercare degli anti-virali efficaci contro il virus SARS CoV-2, si stanno dunque industriando per trovare il modo di gettare acqua sul fuoco delle difese immunitarie fuori controllo, per calmare la reazione immunitaria che rischia di uccidere il paziente. E il cortisone, un classico anti-infiammatorio, contro queste tempeste il più delle volte si rivela un’arma spuntata.

E allora si sta ricorrendo al repertorio di tutti i farmaci utilizzati normalmente contro una serie di malattie autoimmuni, da quelle reumatologiche (lupus, artrite reumatoide, ecc.), a quelle usate dagli ematologi per combattere la graft versus host disease (cioè la reazione dell’organismo contro un trapianto di midollo).
Armi potentissime che silenziano snodi importanti delle difese immunitarie e che vanno usate da mani esperte, senza mai dimenticare che il virus (ma anche le cosiddette infezioni opportunistiche) è pronto a riprendere il sopravvento, se le sentinelle del sistema immunitario non sono più lì a fare il loro dovere.
Le tre fasi dell’infezione COVID-19, dal punto di vista clinico e immunologico
È stato proposto di suddividere la patologia COVID-19 in 3 fasi di severità (https://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(20)31473-X/fulltext). Ce le descrive la prof.ssa Maria Antonietta D’Agostino, professore ordinario di Reumatologia ‘chiamato’ presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e attuale ordinario di Reumatologia presso l’Université Versailles-Saint-Quentin (Francia).
Prima fase. L’infezione ha inizio e il sistema immunitario reagisce contro il virus. Pochi i sintomi, come tosse secca, mal di testa, diarrea, febbricola. Dura 2-7 giorni. In questa fase sarebbe importante agire con un anti-virale mirato per ridurre la carica del virus, impedendone la replicazione; la risposta immunitaria in questo stadio non va bloccata ma ‘aiutata’, eventualmente anche con plasma da convalescenti. Per ora a disposizione solo remdesivir, lopinavir/ritonavir, clorochina e idrossiclorochina. Se si riesce a contenere l’infezione in questa fase ci sono ottime possibilità di guarigione.
Seconda fase (12°-14° giorno). Il virus è entrato nelle cellule, si è riprodotto e ha invaso il polmone (i segni si vedono alla TAC o all’ecografia polmonare). Inizia la fase ipossica, quella che rende a volte necessario il ricovero e la somministrazione di ossigeno (dalla maschera di Venturi, all’intubazione); ci può essere coinvolgimento cardiaco e problemi di coagulazione. Gli esami del sangue mostrano un abbassamento dei linfociti e un aumento delle transaminasi. I marcatori dell’infiammazione sono moderatamente elevati.
Il trattamento consiste in anti-virali e, quando la situazione respiratoria peggiora, si può ricorrere ai cortisonici. Possono comparire sovrainfezioni batteriche da trattare con antibiotici (azitromicina, cefalosporine, fluorchinolonici).
Terza fase. È la fase dell’infiammazione sistemica extra-polmonare; può comparire la ‘tempesta citochinica’ che porta alla sindrome da distress respiratorio (ARDS); i marcatori dell’infiammazione (PCR, LDH, IL-2, IL-6, GCSF, TNF-alfa, D-dimero, ferritina, ecc) sono alle stelle. Anche troponina e NT pro-BNP possono essere elevati (segno di interessamento cardiaco). Il paziente presenta una grave insufficienza respiratoria ed è in collasso cardio-circolatorio (shock). Tutti gli organi sono in tilt.
In questa fase si rende necessario il ricorso alle terapie immunologiche (corticosteroidi, anti-interleuchina 6, come tocilizumab e sarilumab, antagonisti recettoriali di IL-1 come anakinra o canakinumab, JAK-inibitori, plasma da convalescenti) nel tentativo di ridurre la risposta aberrante delle difese immunologiche. La prognosi per chi arriva in questo stadio è molto grave.
Placare e rimodulare la risposta immunitaria è il razionale che sta dietro l’impiego di una serie di farmaci utilizzati in questo momento ‘off label’ (cioè fuori indicazione, perché sono autorizzati per il trattamento di una serie di patologie autoimmuni, dall’artrite reumatoide, alle malattie infiammatorie intestinali) nei pazienti con infezione da coronavirus.
Tocilizumab e Sarilumab. Il primo a scendere in campo è stato il tocilizumab, un anticorpo monoclonale inibitore del recettore dell’interleuchina-6. Più di recente sono partiti i trial clinici sul sarilumab un altro antagonista del recettore per l’interleuchina-6 (utilizzato anche lui nell’artrite reumatoide).
Il 5 marzo la Cina ha approvato il tocilizumab per l’impiego nei casi gravi di infezione da COVID-19. Il farmaco, utilizzato normalmente nell’artrite reumatoide, ‘silenzia’ una citochina specifica, l’interleuchina-6. Non tutti i pazienti rispondono purtroppo al tocilizumab; e adesso si sta dunque cercando di capire quali hanno le maggiori chance di risposta e se il farmaco, somministrato in una fase 3 precoce, possa dare risposte più importanti che se utilizzato solo come terapia di salvataggio, nei pazienti gravissimi.
Nei giorni scorsi l’AIFA ha dato il via libera a sperimentazioni cliniche incentrate su emapalumab (un anticorpo monoclonale anti-interferon gamma) e di anakinra (un antagonista del recettore per l’interleuchina-1).
E anche dal mondo dell’ematologia possono arrivare preziosi suggerimenti su come ‘calmare la tempesta’. È partita da pochi giorni una sperimentazione indipendente, a Cosenza e a Livorno (Usl Toscana Nord Ovest) sul ruxolitinab, un farmaco biologico utilizzato contro la cosiddetta graft versus host disease o ‘malattia del trapianto contro l’ospite’ (una grave complicanza del trapianto di midollo), ma anche nella policitemia vera e nella mielofibrosi. Il farmaco, insieme a baricitinib e fedratinib, appartiene alla famiglia dei JAK inibitori selettivi, utilizzati anche nell’artrite reumatoide e nella mielofibrosi.
Secondo un articolo pubblicato su Lancet Infectious Disease a febbraio, di questi tre, quello che sembra avere le migliori chance di successo, è il baricitinib, perché ha scarsi effetti collaterali e prevede la somministrazione di una sola compressa al giorno.
L’impiego del cortisonici è molto dibattuto. Al momento ci sono diversi protocolli – ricorda la prof.ssa D’Agostino – tra quelli che dicono di iniziarli a basso dosaggio durante la fase 2 e mantenerli sempre, e quelli che consigliano di utilizzarli in vena a dosaggi più elevati solo nel momento in cui il paziente va in distress respiratorio.
Il problema dei cortisonici è che hanno molti effetti indesiderati; in più questi pazienti sono gravati da problemi della coagulazione e soprattutto (in particolare per i pazienti in rianimazione) dal rischio di sovra infezioni batteriche polmonari. Insomma, l’indicazione, la durata e il dosaggio della terapia cortisonica non sono ancora stati definiti con precisione.