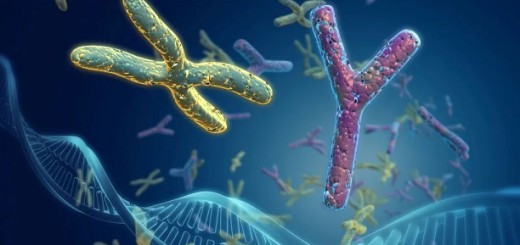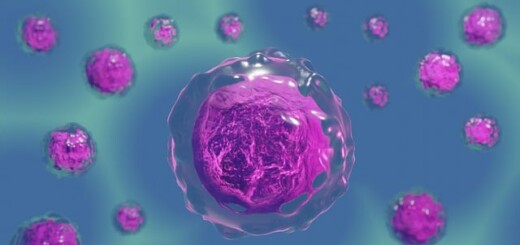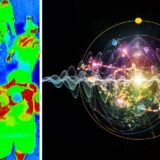Attraversando la nebbia
 In ogni opera di creazione, anche se in diversa forma, emerge sempre un tratto autobiografico. Ci riferiamo, in questo caso, a generi di scrittura, quali il diario, le memorie, il romanzo autobiografico, dove i temi tendono a mescolarsi fra loro e a confondersi in un tumultuoso processo di elaborazione. Per questo motivo il critico francese Philippe Lejeune ha proposto il “Patto autobiografico”, un accordo implicito fra chi scrive e chi legge, basato sulla veridicità delle affermazioni riportate.
In ogni opera di creazione, anche se in diversa forma, emerge sempre un tratto autobiografico. Ci riferiamo, in questo caso, a generi di scrittura, quali il diario, le memorie, il romanzo autobiografico, dove i temi tendono a mescolarsi fra loro e a confondersi in un tumultuoso processo di elaborazione. Per questo motivo il critico francese Philippe Lejeune ha proposto il “Patto autobiografico”, un accordo implicito fra chi scrive e chi legge, basato sulla veridicità delle affermazioni riportate.
L’intesa a riguardo si rese necessaria perché la “scrittura di sé” è un oggetto sfuggente e inafferrabile. Si pensi al tratto narcisistico del raccontarsi, a quell’offrirsi al mondo con la necessità di un testimone. Si pensi al “Notturno” di Gabriele D’Annunzio, alla “Autobiografia di un genio” di Salvador Dalì o al singolare, “Sono apparso alla Madonna” di Carmelo Bene. Esempi magistrali di provocazione, di autoaccusa, di autoanalisi, dove la struttura stilistica consente la convivenza di memoria e di finzione.
In questo periodo l’interesse verso le biografie è molto forte perché alta è la tendenza a identificarsi nella vita dei personaggi narrati. Si vuole carpirne le fantasie, i desideri, le ragioni del successo o della rovina. Numerosi sono dunque i lettori e folta la schiera degli “scrittori autobiografici”. Si è convinti, erroneamente, che questo genere rappresenti la strada più agevole per chi voglia cimentarsi nella scrittura. In verità scrivere di sé richiede molta fatica. Per compiere l’opera bisogna accostarsi alla propria vita, riunire elementi disarticolati, attivare funzioni razionalizzanti. È necessario estraniarsi per ricostruire la propria storia, vincere incongruità e causalità. Essenziale sarà la ricerca di un punto di arrivo che restituirà senso al racconto che abbiamo “preteso sapere” di noi.
A volte si proporrà “il racconto che non c’è”, prodotto di vuoti e di sospensioni. In questo caso sarà l’ausilio di un canovaccio ad alleviare la sgradevole sensazione di aver vissuto un’esistenza fortuita e occasionale.
Il lavoro autobiografico, organizzato attraverso il racconto, la memoria, l’ordine del discorso, si rivelerà come una vera e propria “fenomenologia della presentazione di sé”. In questa luce svelerà tratti in comune con quelle narrazioni cliniche, proprie della stanza dell’analisi. Il pensiero narrativo, infatti, consente alla mente di esprimersi a più livelli attraverso l’uso delle parole. Sarà il mondo interno a esprimere se stesso tramite il linguaggio, saranno le rappresentazioni delle vicende quotidiane a mostrare il funzionamento delle funzioni mentali. Eppure, fra i due universi insisteranno delle differenze. Se nella biografia si stabilirà una “congiunzione” fra chi racconta e la persona di cui si narra, nella psicoterapia il referente del racconto rimarrà il terapeuta, oggetto di ogni dinamica trasferale.
L’autoanalisi, nelle sue forme diverse, è peculiare sia dell’adolescenza, sia dell’età matura. L’adolescente nei suoi lavori esprimerà il non detto e il presente incomberà nelle sue pagine. Il diario degli adulti, diversamente, sarà intriso di sentimenti di perdita, ingombrante di passato, dove la rêverie assumerà i caratteri della scoperta e della ricerca di sé.
Nuove difficoltà si profileranno all’orizzonte. Il racconto autobiografico proporrà un’immagine ideale dello scrivente e così il rischio della mistificazione e della costruzione di una “falsa storia” sarà alto. È probabile che si presenterà, inconsciamente, come pensava D. W. Winnicott, un falso sé, ovvero un’immagine compiacente verso chi ascolterà o verso chi leggerà. E in questa lotta, diceva Nietzsche, sarà la memoria, ancora una volta, a soccombere. Il lavoro autobiografico, dunque, si legherà a fili esilissimi che guideranno il cammino nella nebbia verso tasselli ritenuti perduti. Se il compito riuscirà, si creerà qualcosa che somiglia alla nostra vita.