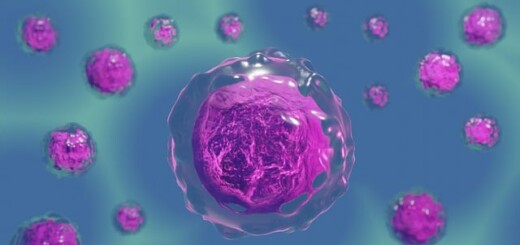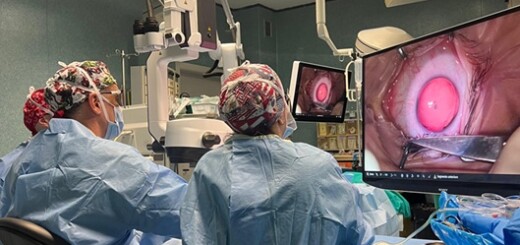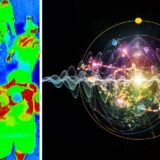Alzheimer, screening genetico per ritardare o addirittura impedire lo sviluppo della demenza

A cura del prof. Alessandro Padovani, Direttore Clinica Neurologica Università di Brescia

Anche in tempo di Covid, la ricerca sulla Malattia di Alzheimer non si ferma. Anzi, nonostante il clamore suscitato in tutto il mondo dalla pandemia, sono molte le novità emerse in questo ultimo anno sia dal punto di vista dei fattori di rischio, sia dal punto di vista diagnostico, sia dal punto di vista terapeutico e il prossimo Convegno Nazionale della Società Italiana di Neurologia sarà un’occasione importante per discutere su dove sta andando la ricerca internazionale e nazionale soprattutto nell’ambito della Malattia di Alzheimer e della altre principali forme di demenza.
Un primo dato interessante riguarda gli studi di incidenza. Già era stato osservato che, a parità di età, nei paesi occidentali vi è una progressiva riduzione dell’incidenza a fronte di un aumento della prevalenza. Si stima infatti che attualmente nel mondo siano più di 130 milioni i pazienti affetti da demenza e più della metà da Malattia di Alzheimer.

A fronte di ciò, secondo uno studio condotto dal gruppo di Laura Fratiglioni, a parità di età il numero di malati si è ridotto negli ultimi 10 anni del 20%. Il paradosso è solo apparente. Infatti, migliori cure unitamente all’incrementato tasso di scolarizzazione e alfabetizzazione hanno allungato l’aspettativa di vita e il tasso di invecchiamento della popolazione, e quindi il numero di persone anziane, ma hanno favorito un maggiore stato di salute e un minor rischio di sviluppare demenza.
A tal riguardo uno studio pubblicato su Lancet pochi mesi fa da Gill Livingston e collaboratori ha permesso di fare il punto sui diversi fattori di rischio associati alla Malattia di Alzheimer e sulla possibilità di poter prevenire la Malattia attraverso un controllo o un intervento attivo su di essi.
Oltre ai già citati fattori di rischio cardiovascolari, che includono diabete, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, obesità, lo studio ha individuato diversi altri possibili bersagli quali la sedentarietà, il fumo di sigaretta, l’eccessivo consumo di alcool e di bevande zuccherate, oltre alla sordità, all’esposizione all’inquinamento ambientale, l’isolamento sociale e la depressione.
Questi sembrano i più rilevanti, ma diversi studi includono tra i fattori di rischio anche i disturbi del sonno e l’eccessivo uso di ansiolitici, una dieta eccessivamente ricca di carboidrati e di sale nonché una scarsa igiene orale.
Di notevole interesse un recente studio del gruppo di Bruno Vellas che sembra individuare in una bassa concentrazione plasmatica di vitamina D, vitamina B12 e di una bassa concentrazione di acidi grassi polinsaturi (vedi n-3 PUFA) gli indicatori più significativamente associati ad un decadimento cognitivo. Questa crescente mole di dati indica la necessità di attivare programmi di prevenzione attiva agendo sugli stili di vita e sulla somministrazione di integratori nutrizionali soprattutto nei soggetti a rischio.
La ricerca genetica ha fatto enormi passi avanti e stiamo procedendo verso il traguardo di caratterizzare i soggetti a rischio. Ad oggi, diverse indagini hanno permesso di individuare mutazioni e polimorfismi su numerosi geni, la cui combinazione potrebbe presto portare a un profilo di rischio. Fantascienza? Non proprio. In realtà, come avviene già per il cancro e per le malattie cardiache, lo screening genetico potrebbe aiutare a selezionare i casi nei confronti dei quali attivare un programma di sorveglianza e di intervento per ritardare se non addirittura impedire lo sviluppo della demenza.
Un aspetto fondamentale per combattere la Malattia di Alzheimer è la diagnosi precoce. Infatti, non solo è importante individuare i soggetti a rischio, ma ancora di più è individuare coloro che hanno già la Malattia prima ancora che siano evidenti i primi sintomi. In altre parole, per un trattamento mirato ed efficace il tempo è prezioso anche per la Malattia di Alzheimer.
Un gruppo di ricercatori svedesi coordinati da Henrik Zetterberg e Oskar Hansson ha individuato una proteina, p-Tau217, nel plasma la quale risulta correlata alle alterazioni neuropatologiche tipiche di questa malattia, dimostrando che elevati valori predicono la presenza della malattia con una accuratezza superiore all’80%. In altre parole, si avvicina il traguardo di una diagnosi mediante un prelievo ematico.
Non solo. Diversi studi pubblicati in questi ultimi mesi hanno confermato la possibilità di caratterizzare diverse proteine nel plasma correlate alla Malattia di Alzheimer quali i neurofilamenti, la proteina gliale fibrillare, i frammenti d’amiloide, alcune citochine, le quali potrebbero essere utilizzate quali marcatori surrogati per valutare l’efficacia di farmaci permettendo in questo modo di monitorare eventuali trattamenti oppure di combinare diversi trattamenti in forma ‘personalizzata’.
Ma anche le neuroimmagini rivestono un ruolo fondamentale nel percorso diagnostico. Come riportato in questo Convegno dal gruppo della Prof.ssa Daniela Perani di Milano, l’utilizzo della PET FDG è in grado di predire l’accumulo della amiloide nel cervello e risulta di grande utilità nell’identificare anche altre forme di decadimento cognitivo anche iniziale.
Di grande interesse i dati provenienti dal gruppo di Firenze coordinato da Sandro Sorbi e Benedetta Nacmias di Firenze che sottolineano l’utilità di combinare marcatori diversi per una maggiore accuratezza diagnostica proponendo di associare la PET per l’amiloide e i biomarcatori liquorali per una precisa identificazione di pazienti in fase iniziale.
Un aspetto spesso trascurato riguarda la sintomatologia psichiatrica o mentale. Infatti, molti casi all’esordio non manifestano disturbi mnesici o cognitivi mentre invece manifestano alterazioni del comportamento, come riportato dallo studio della prof.ssa Cagnin di Padova e collaboratori secondo il quale circa il 50% delle manifestazioni psichiatriche in tarda età sono riconducibili a patologia neurodegenerativa.
Diversi studi hanno caratterizzato altre forme di demenza meno note ma comunque frequenti quali la Demenza Fronto Temporale. Infatti il gruppo del prof. Filippi e della prof.ssa Agosta di Milano ha individuato alcune caratteristiche specifiche, usando la RMN, a carico della sostanza grigia e del cervelletto che permetterebbero di identificare alcune forme particolari associate al gene C9ORF. Il gruppo di Pisa coordinato dal prof. Bonuccelli invece ha individuato nella Malattia di Alzheimer e altre forme degenerative alterazioni precoci a carico di un nucleo, il Locus Ceruleus , coinvolto nei meccanismi del tono dell’umore.
Meritevole infine nell’ambito della diagnosi precoce, lo studio di un gruppo multicentrico coordinato dalla prof.ssa Bonanni e prof. Onofrj che ha individuato mediante l’utilizzazione di un sofisticato strumento EEG alcune alterazioni della organizzazione corticale che permetterebbero di differenziare la M. Alzheimer dalla Demenza Fronto-Temporale
Quali i trattamenti disponibili? Per adesso dobbiamo limitarci a somministrare farmaci come gli anticolinesterasici e memantina, ma non sarà per molto. Diversi studi hanno confermato che la somministrazione di terapie biologiche per mezzo di anticorpi contro l’amiloide così come di farmaci in grado di interferire con il metabolismo di questa proteina, non solo riduce l’accumulo di placche senili e la degenerazione neurofibrillare, ma soprattutto migliora la progressione della malattia.
Non siamo ancora al punto da dichiarare sconfitta la malattia di Alzheimer ma certo i dati ottenuti sono molto incoraggianti, soprattutto se il trattamento viene somministrato nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer. Altri studi sono in corso con farmaci simili ed è opinione largamente condivisa che le terapie immunologiche e a seguire diversi altri farmaci potranno essere disponibili e accessibili anche in Italia. Sicuramente la strada per la cura della Malattia di Alzheimer è ancora lunga ma perlomeno sappiamo quale è la direzione per curarla.