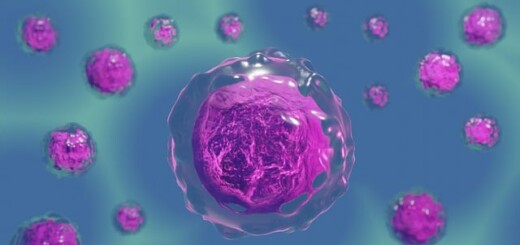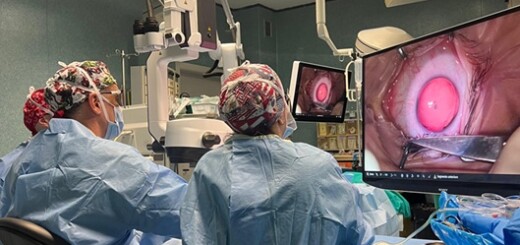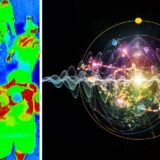Alzheimer, problemi di memoria campanello d’allarme. Il punto della ricerca sulle procedure diagnostiche
A cura del prof. Stefano Cappa Ordinario di Neurologia, Scuola Universitaria Superiore di Pavia. “I dati attualmente disponibili parlano di circa 500.000 persone con demenza di Alzheimer in Italia, e di una popolazione di più di 700.000 soggetti ‘a rischio’, in quanto affetti da problemi di memoria che possono rappresentare una fase iniziale della malattia”
Milano, 9 marzo 2018 – I recenti annunci da parte di importanti case farmaceutiche di fallimenti, o addirittura sospensioni, della ricerca nel campo delle terapie per la malattia di Alzheimer ha destato preoccupazione in una opinione pubblica sempre più consapevole riguardo all’impatto medico, ma anche economico e sociale di questa patologia.
È infatti ormai conoscenza comune che l’invecchiamento della popolazione, legato all’aumento dell’attesa di vita che coinvolge anche i Paesi in via di sviluppo, porta con sé inevitabilmente un incremento delle malattie legate all’età, tra cui un posto centrale hanno le patologie degenerative del sistema nervoso.
I dati attualmente disponibili parlano di circa 500.000 persone con demenza di Alzheimer in Italia, e di una popolazione di più di 700.000 soggetti ‘a rischio’, in quanto affetti da problemi di memoria che possono rappresentare una fase iniziale della malattia.
In realtà i progressi nella comprensione dei meccanismi di malattia, nello sviluppo di metodi diagnostici e nella individuazione di possibili fattori di prevenzione sono continui, e la ricerca neurologica italiana ha un ruolo da protagonista.
Alcuni risultati recenti: la scoperta che nei soggetti che presentano un accumulo cerebrale della proteina beta-amiloide, un importante marcatore biologico della malattia, presentano uno sbilanciamento della flora batterica intestinale, con aumento dei ceppi pro-infiammatori e diminuzione dei ceppi batterici ad azione anti-infiammatoria; lo sviluppo di un metodo non invasivo e poco costoso, basato sulla stimolazione magnetica, per distinguere i pazienti affetti da Alzheimer da quelli colpiti da un’altra malattia neurodegenerativa, la demenza fronto-temporale; l’individuazione di un potenziale effetto protettivo del bilinguismo sulla evoluzione della malattia di Alzheimer. In tutte e tre questi studi, pubblicati su riviste internazionali molto importanti, fondamentale è stato il ruolo di giovani ricercatori non strutturati o all’inizio della carriera.
A livello internazionale, due scoperte sono molto importanti per il potenziale impatto sulla diagnosi e sullo sviluppo di nuove terapie. Da un lato, una scoperta di base, ovvero la delucidazione della precisa struttura atomica di un’altra proteina la cui deposizione a livello cerebrale, accanto a quella dell’amiloide, è il principale marcatore della malattia, ovvero la tau fosforilata.
La conoscenza della struttura degli aggregati specifici per l’Alzheimer apre la strada alla possibilità di una visualizzazione in vivo, con la tomografia ad emissione di positroni, e allo sviluppo di terapie che ne blocchino l’aggregazione.
Dall’altro, il recentissimo annuncio di un test eseguibile su un semplice campione di sangue, la cui efficacia nel dimostrare la presenza di un probabile accumulo di amiloide cerebrale sembra comparabile a quella di esami invasivi, come l’analisi del liquido cerebrospinale mediante puntura lombare, o più costosi e complessi, come la PET cerebrale con traccianti per l’amiloide, apre prospettive nuove per la diagnosi precoce e la valutazione dell’efficacia di terapie applicate a soggetti a rischio o nelle fasi iniziali di malattia.