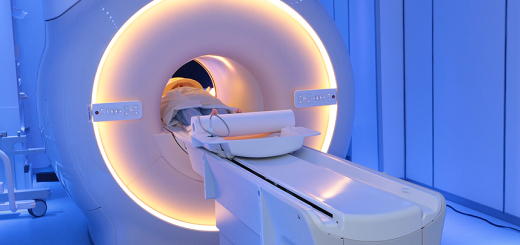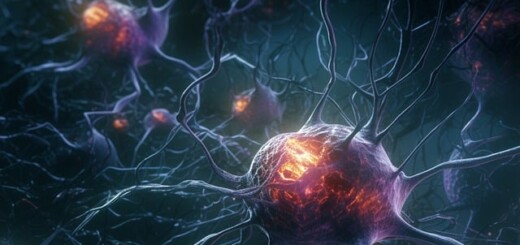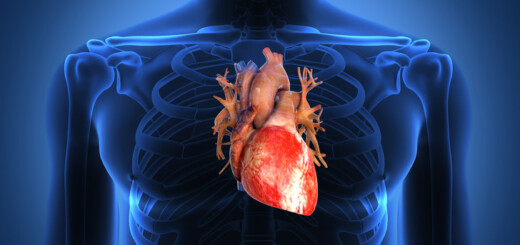A cura del prof. Paolo Maria Rossini, Direttore Dipartimento Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’IRCCS San Raffaele – Roma

Roma, 18 settembre 2023 – Avevamo chiuso il 2022 con un po’ di amaro in bocca per malati, famiglie e addetti ai lavori legato al fatto che il primo farmaco che aveva dimostrato una qualche efficacia nel modificare l’andamento naturale della malattia approvato negli USA (Aducanumab il nome della molecola) non era stato poi approvato in Europa (e quindi in nessuno dei Paesi EU) a causa di una serie di motivazioni peraltro per lo più condivisibili: scarsa efficacia clinica, effetti collaterali relativamente frequenti e talvolta allarmanti, elevati costi diretti e indiretti (inclusi quelli organizzativi per l’erogazione ospedaliera e il monitoraggio degli effetti collaterali).
Il 2023 si è aperto con l’approvazione da parte dell’FDA di un altro anticorpo monoclonale contro la beta-amiloide (come Aducanumab) il cui percorso approvativo è ora all’attenzione delle autorità dell’Ente europeo per il farmaco. La molecola si chiama Lecanumab; in questo caso l’efficacia sembra maggiore, gli effetti indesiderati molto minori, mentre permangono irrisolti i problemi relativi ad i costi diretti e indiretti.
Come era prevedibile, aperta la porta da Aducanumab, si sarebbe assistito a un progressivo ingresso di nuove molecole che sono in grado di rallentare l’evoluzione della malattia. Ci sono infatti diversi farmaci in attesa di terminare la loro Fase III che, se corroborata da risultati positivi, permette poi la richiesta di immissione sul mercato; alcuni di questi sono somministrabili sottocute (come l’insulina per il diabete) e non richiederebbero quindi una onerosa e costosa fase di distribuzione ospedaliera quale quella richiesta per effettuare una flebo.

Tra questi mi pare utile segnalare quello con il Valitramilprosato perché sarebbe la prima formulazione assumibile per bocca, perché agirebbe non solo su beta-amiloide, ma anche su tau (un altro ‘killer’ alla base della formazione dei grovigli neurofibrillari all’interno dei neuroni attaccati dai processi neurodegenerativi), avrebbe pochissimi effetti collaterali e di scarso rilievo e sembrerebbe in grado di bloccare l’evoluzione della malattia.
L’uso di tanti condizionali è d’obbligo poiché tutte le informazioni sin qui disponibili arrivano dalla Ditta produttrice e necessitano quindi di una valutazione approfondita da parte di un comitato neutrale non appena la medesima Ditta dovrà aprire i propri archivi per mostrare i dati originali al fine di iniziare un percorso approvativo.
E intanto ora cosa si fa? Ci sono i soliti farmaci ‘sintomatici’ con tutti i limiti ben noti, c’è l’attenzione sullo stile-di-vita (sempre più solidi sono le evidenze scientifiche a supporto del fatto che fare ginnastica tutti i giorni e dedicare tempo ad attività cognitive aumenta la resistenza dei neuroni e dei circuiti nervosi superstiti) e sui fattori di rischio da ridurre o eliminare del tutto (obesità, fumo, eccesso di alcool, controllo diabete, controllo pressione, controllo cardiopatie etc.).
Infine, stanno emergendo ipotesi di trattamento che attualmente dobbiamo ancora considerare sperimentali in cui si utilizzano vari tipi di energie (campi magnetici pulsanti, correnti elettriche di bassa intensità, ultrasuoni focalizzati, onde d’urto) in grado di attivare in modo selettivo (le sonde di stimolazione vengono guidate dalle immagini del cervello di quel determinato paziente tramite tecniche di neuronavigazione) facendo impattare l’energia in uso sulle ‘centraline’ cerebrali particolarmente importanti per la memoria, l’orientamento, il linguaggio, il tono dell’umore etc.
Sembra che sedute quotidiane della durata di alcune decine di minuti, ripetute dal lunedì al venerdì per 3 o 4 settimane consecutive siano in grado di mantenere o addirittura di migliorare le funzioni connesse ai circuiti stimolati per i 6-12 mesi successivi.
E in Italia? A fine ottobre terminerà l’importante progetto nazionale INTERCEPTOR voluto e finanziato dal Ministero della Salute e da AIFA (l’Agenzia Italiana per il farmaco) che per quasi 5 anni ha monitorato oltre 350 soggetti con una forma molto iniziale di declino cognitivo in tutta Italia.
All’inizio dello studio in tutti i soggetti reclutati sono stai raccolti dei ‘biomarcatori’ di sangue (per la genetica), di liquor (per dosare i ‘killer’ più noti quali beta amiloide e tau), di immagini (Risonanza Magnetica per misurare il volume dell’ippocampo e PET per misurare il metabolismo delle aree cerebrali), di elettroencefalogramma (per misurare le connessioni cerebrali e l’architettura delle reti neurali) e infine di test neuropsicologici avanzati.
Poiché nel corso del follow-up poco meno di un centinaio dei soggetti reclutati è diventato ‘demente’ (cioè ha sviluppato la malattia vera e propria), al termine del follow-up si potrà capire quale combinazione di biomarcatori è stata in grado di prevedere con il massimo di accuratezza l’eventuale progressione dei sintomi già al tempo 0 quando questi erano minimi e non costituivano un quadro di demenza vera e propria.
Con queste informazioni l’Italia diverrà probabilmente il primo Paese ad avere uno strumento validato per identificare (intercettare) nelle fasi molto iniziale i soggetti che sono ad alto rischio di divenire dementi e di concentrare su questi tutti gli interventi terapeutici e riabilitativi disponibili inclusi gli eventuali farmaci in arrivo la cui efficacia (questo è un dato ricorrente) è tanto maggiore quanto prima vengono somministrati nelle fasi iniziali di malattia.

 Salva come PDF
Salva come PDF