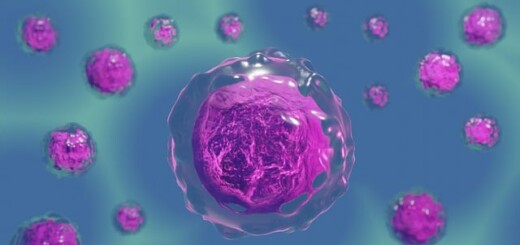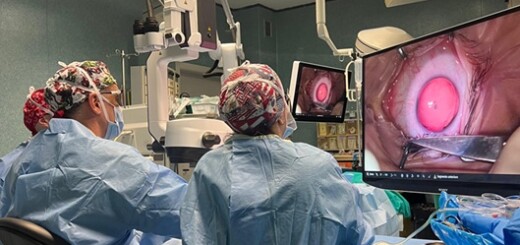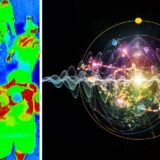Ebola in Uganda, viaggio nella task force che ha bloccato il virus

Intervista al dott. Patrick Kagurusi Country Manager Amref Health Africa Uganda

Roma, 18 gennaio 2023 – Non solo scienza medica: mobilizzazione delle comunità, pratiche funebri non convenzionali a prova di contagio e speciali rituali di di reinserimento nelle comunità – a quattro mesi dal primo caso confermato, pochi giorni fa è stata dichiarata dall’OMS la fine dell’epidemia di ebola virus in Uganda.
Resistenza e negazione, riti funerari ad alto rischio di contagio e stigma nei confronti di chi è ormai guarito sono le sfide principali riscontrate in questi mesi di emergenza. La presenza capillare sul territorio di organizzazioni come Amref, il rapporto di fiducia e collaborazione instaurato con i capi e i leaders religiosi, e il retaggio della pandemia da Covid sono gli elementi che hanno contribuito a porre fine all’epidemia.
“In questo momento c’è una sensazione di sollievo per la fine di questa epidemia: le persone stanno tornando alle proprie attività, le scuole riapriranno presto, la vita sta tornando alla normalità”, afferma il dott. Patrick Kagurusi Country Manager Amref Health Africa Uganda.
Partendo dall’inizio, qual è stata la reazione della popolazione quando sono stati accertati i primi casi?
Non ci sono cure o vaccini per questa variante di ebola virus , l’unico modo per arginare il contagio è la prevenzione attraverso la diffusione di informazioni e norme di comportamento, e l’isolamento dei casi sospetti. Inizialmente la sfida più grande è stata quella di riuscire a convincere la popolazione della pericolosità di questo virus e della necessità di collaborazione.
C’è chi per esempio riconduceva i sintomi a una condizione spirituale, rivolgendosi a guaritori, chiese, stregoni, per vedere se avessero una soluzione. Per questo motivo è stata cruciale la presenza capillare sul territorio e la collaborazione con le voci più autorevoli nelle comunità, come i leader e le guide spirituali.
Queste comunità sono organizzate in modo tale da avere operatori sanitari di prossimità, responsabili di portare i messaggi e i presidi sanitari direttamente nei villaggi, un collegamento diretto tra le istituzioni e il territorio.
Amref lavora con oltre 30.000 di questi operatori sanitari di comunità nel Paese, e proprio grazie a questa presenza e il rapporto di fiducia instaurato con la popolazione è stato possibile contenere e sconfiggere l’epidemia in soli quattro mesi.
Dal punto di vista tecnico, quali sono state le strategie messe in atto?
Questa epidemia è arrivata sulla scia di quella del Covid-19. Esisteva quindi già una struttura, di cui Amref faceva parte, un centro di coordinamento delle emergenze sanitarie coordinata dal Ministero della Salute. Non appena è stata dichiarata l’emergenza, il primo passo è stato la comunicazione: usare tutti i canali attivi e i nostri operatori sul campo per diffondere informazioni utili sulla malattia, sui sintomi e i protocolli da seguire.
Il secondo passo è stato quello di costituire all’interno della nostra organizzazione, come team, una piccola task force per lavorare alla risposta. Abbiamo già un comitato permanente che si è occupato dell’epidemia di Covid e ora è stato in grado di assumersi la responsabilità dell’ebola. Infine, abbiamo deciso di coinvolgere i nostri donatori per poter reindirizzare dei fondi da destinare all’intervento.
Durante il focolaio del 2014-2015 in Africa Occidentale l’epidemia è stata sostenuta principalmente da una trasmissione interumana diretta, ad esempio durante eventi come le cerimonie funebri.
Durante le precedenti epidemie da ebola, le pratiche funebri hanno giocato un ruolo centrale nella diffusione del virus: toccare i cadaveri, vestirli, portare rispetto attraverso rituali che prevedono il contatto, tutto ciò è stato severamente proibito questa volta.
L’Uganda ha istituito alcune squadre speciali che si occupano dei corpi di coloro che sono morti, alle comunità non è stato permesso di seppellire nessuno. Per ottenere la complicità della popolazione, i leader religiosi hanno esonerato i seguaci dal lavare il defunto con le mani e hanno permesso di pregare mantenendo una distanza di 2 metri dal corpo.
Per proteggere i vivi, i cadaveri (altamente contagiosi) devono essere maneggiati da operatori che indossano tutti i DPI, e si deve procedere a un’indagine approfondita sul caso che includa l’immediata rintracciabilità dei contatti. Tutto ciò è molto diverso dalla pratica tradizionale di lavare i corpi dei propri cari con le mani.
Le squadre, gestite dal governo ed adeguatamente equipaggiate, sono state supportate anche dalla polizia e dall’esercito, per assicurarsi che fosse applicato il protocollo e proteggere l’intera comunità. Non è facile rinunciare a pratiche che aiutano le persone a elaborare il lutto. Con l’esperienza del Covid, la popolazione è sempre più consapevole della necessità di questo protocollo di lutto ‘straordinario’, che si è decisamente normalizzato.
Cosa succede dopo che l’epidemia viene ufficialmente dichiarata conclusa?
Il periodo di incubazione del virus è di 21 giorni, per cui una volta dimesso l’ultimo paziente, il protocollo prevede l’attesa di 42 giorni che accerti che nessun altro contagio sia avvenuto.
Una volta accertata, l’epidemia può essere dichiarata conclusa, ma rimaniamo comunque in allerta che non si ripresenti l’emergenza altrove. Per il personale sanitario è previsto un periodo di riposo, perché lavorare nei reparti dedicati all’ebola o sul campo è psicologicamente e fisicamente molto duro, oltre che pericoloso. Sono infatti loro ad essere più esposti al rischio di infezione: solo durante questo focolaio, sono stati contagiati 18 operatori sanitari (su 155 casi totali confermati), di cui 7 hanno sfortunatamente perso la vita.
C’è un programma per i sopravvissuti al virus che fornisce supporto psicosociale, consulenza e istruzione alla comunità sul fatto che, sebbene queste persone abbiano contratto l’Ebola, ora non sono più infette e devono essere reintegrate nella società come persone normali.
C’è ancora tanto stigma nei confronti di chi è guarito dal virus dell’ebola, che viene spesso isolato con il timore che sia ancora contagioso o non del tutto guarito. È importante quindi anche seguire le persone nel loro reinserimento nelle comunità attraverso un processo di reintegrazione.
Questo avviene attraverso prove concrete che dimostrino la completa guarigione: quando il paziente guarito tornerà a casa, verrà accompagnato da un consulente della struttura sanitaria, lo abbraccerà, gli stringerà la mano e passerà del tempo a contatto con lui. I leader locali hanno organizzato cerimonie comunitarie per dare il bentornato a chiunque avesse completato la quarantena, con un pacchetto di reintegrazione di cibo, denaro e vestiti.
Le visite proseguono poi per assicurarsi che il paziente stia bene e che la comunità non abbia più paura di lui.