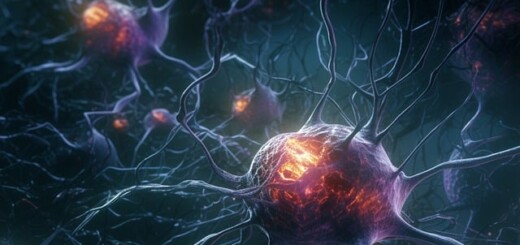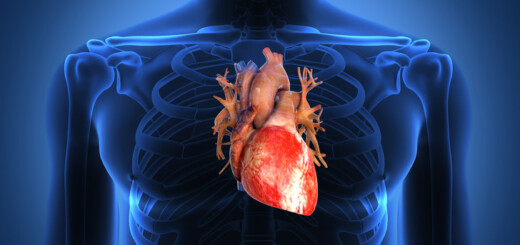Milano, 6 luglio 2018 – Ipovitaminosi D significa carenza di vitamina D: una definizione apparentemente semplice ma in realtà al centro di una dibattuta controversia scientifica. Qual è il marcatore biologico o biochimico che può meglio identificare un paziente ad alto rischio di ipovitaminosi? Quali sono i valori di cut-off che definiscono un reale deficit di vitamina D?
A queste domande che sono cruciali per gli specialisti e soprattutto per i pazienti data l’importanza di questa sostanza per il loro benessere viene data una risposta nel paper “Vitamin D: Assays and the Definition of Hypovitaminosis D: Results from the 1st International Conference on Controversies in Vitamin D”, pubblicato pochi giorni fa sulla prestigiosa rivista British Journal of Clinical Pharmacology, frutto del summit che lo scorso anno ha riunito oltre 25 esperti provenienti da tutto il mondo in una tre giorni scientifica dedicata all’ormone del sole, la Vitamina D.
“Nonostante tutte le controversie che ruotano intorno alla Vitamina D, il suo ruolo essenziale nella salute dell’osso è noto da oltre un secolo e generalmente, quanto si riscontra uno stato di ipovitaminosi D si interviene somministrando il colecalciferolo o altri precursori della vitamina D – afferma il prof. Andrea Giustina, Professore Ordinario di Endocrinologia al San Raffaele di Milano e Presidente GIOSEG -Trattandosi di un ormone, e non di una vitamina come erroneamente si crede, è fondamentale quindi accertarne il deficit, definire la gravità della carenza nel singolo individuo: questo ci permette di intervenire in forma personalizzata”.
Ad oggi, il dosaggio sierico del metabolita circolante, la 25 idrossi-vitamina D [25 (OH) D], è considerato il gold standard per valutare lo stato vitaminico D e, nonostante vi siano diverse definizioni di ipovitaminosi proposte da diverse società scientifiche e istituzioni nazionali ed internazionali, la sua concentrazione nel sangue è considerata il miglior biomarker.
Il consenso raggiunto dagli esperti riunitisi a Pisa è che valori di [25 (OH) D] inferiori a 12 ng/ml riflettono una condizione sfavorevole per la salute ossea, un ridotto assorbimento del calcio, una scarsa mineralizzazione ossea e vengono associati ad un aumentato rischio di rachitismo e/o di osteomalacia; solo però quelli superiori a 20 ng/mL sono considerati sicuri e sufficienti per la salute dell’osso.
“Questo consenso è a suo modo storico in quanto per la prima volta sono state individuate soglie ideali e condivise dai più grandi esperti espressi dalla comunità scientifica per definire una condizione carenziale o di insufficienza di Vitamina D. Questo non vuol dire che tutti i problemi in questo ambito siano risolti:infatti, se da un lato non abbiamo ancora raggiunto una standardizzazione a livello mondiale delle tecniche di misurazione, dall’altro, dagli studi clinici ci arrivano talvolta risultati contradditori spesso legati proprio alle soglie di intervento – continua Giustina – Questi due aspetti sono due facce della stessa medaglia infatti gli effetti della somministrazione di vitamina D variano molto a seconda della condizione più o meno carenziale di partenza”.
“La supplementazione su soggetti carenti mostra, infatti, effetti significativi, mentre su soggetti mediamente non carenti, non ci si possono attendere risultati altrettanto validi. La definizione di ipovitaminosi D a cui sono giunti gli esperti ne rappresenta un importante passo avanti per la gestione clinica sulla base di criteri condivisi a livello internazionale. Le prossime consensus daranno l’opportunità a questo gruppo di esperti di affrontare i problemi ancora sul tappeto”, conclude Giustina.



 Salva come PDF
Salva come PDF